Perché i professionisti hanno ragione a ignorare questa visione dell’“era AI” per la supply chain
Quando una quarantina di professori e figure dell’industria pubblicano una “vision statement” per la supply chain nell’era AI, ci si potrebbe aspettare qualcosa che aiuti un vero professionista della supply chain a prendere decisioni migliori lunedì mattina.
Il documento a cui faccio riferimento è Supply Chain Management in the AI Era: A Vision Statement from the Operations Management Community di Maxime Cohen, Tinglong Dai, Georgia Perakis e trentanove co‑autori. Nell’abstract viene annunciato che la comunità dell’operations management (OM) ha “un ruolo e una responsabilità importanti” non solo nel plasmare come l’AI trasforma le supply chain, ma anche nel garantire che le supply chain che rendono possibile l’AI siano “sostenibili, resilienti ed eque.” Successivamente, viene sviluppato un framework a cinque livelli — intelligence, execution, strategy, human, infrastructure — e viene esaminato un vasto corpo di letteratura su OM e AI attraverso tale prisma.
Su carta, ciò suona promettente. In pratica, è una quasi perfetta illustrazione del perché i professionisti della supply chain abbiano ragione a ignorare la maggior parte della produzione accademica nel nostro campo.
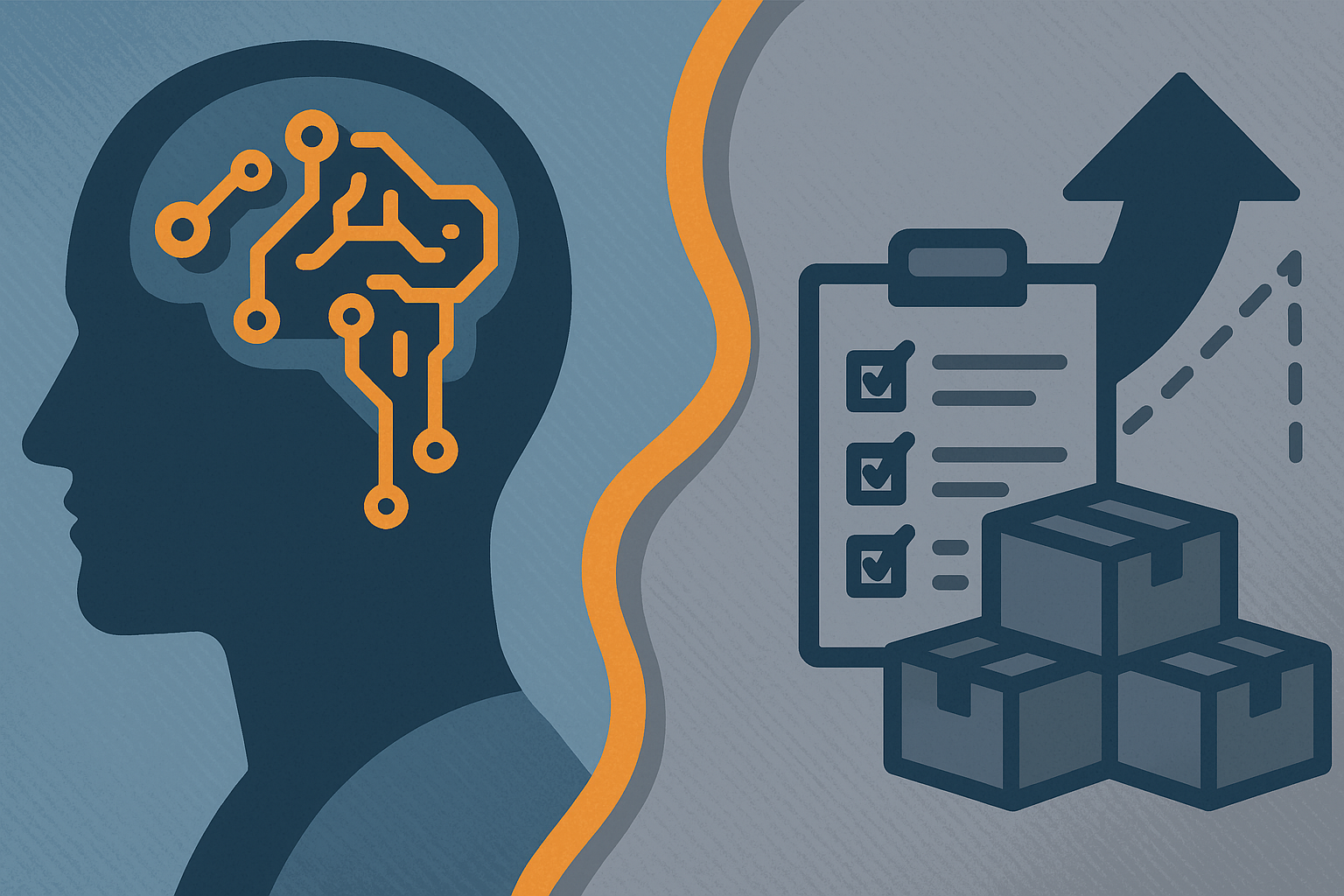
Nel mio recente libro Introduction to Supply Chain, definisco la supply chain come la padronanza delle opzioni in condizioni di incertezza nel flusso di beni fisici e sostengo che, in un’economia di mercato, l’obiettivo pratico della supply chain sia incrementare il tasso di rendimento rettificato per il rischio di ogni risorsa scarsa con cui l’azienda interagisce — capitale, capacità, tempo, goodwill. Tutti i soliti desiderata — livelli di servizio più elevati, tempi di consegna più brevi, trasporti più ecologici, dipendenti più soddisfatti — importano solo nella misura in cui contribuiscono ai profitti a lungo termine espressi in valuta forte. La supply chain non è filosofia morale; è economia applicata che sopravvive o perisce in base al bilancio.
Considerata con questo metro di giudizio, questa “vision statement” fa scattare quasi tutte le bandiere rosse che ho imparato a diffidare nella scrittura accademica sulla supply chain: signaling di virtù supra‑economiche, framework che non toccano decisioni reali, una valanga di citazioni autoreferenziali e la persistente convinzione che un ulteriore strato di modelli di serie temporali unito all’AI moderna possa in qualche modo riscattare il paradigma della pianificazione che ha già fallito i professionisti per decenni.
Permettetemi di spiegare il perché.
Virtù Supra‑economiche e l’Etica dei Bilanci altrui
La frase più rivelatrice dell’intero documento appare nell’abstract:
“La comunità OM ha un ruolo e una responsabilità importanti nel guidare non solo il modo in cui l’AI trasforma le supply chain, ma anche il modo in cui le supply chain che abilitano l’AI vengano concepite per essere sostenibili, resilienti ed eque.”
La conclusione ripete lo stesso trio di virtù, dichiarando che l’OM dovrebbe guidarci verso supply chain che siano “più resilienti, eque e sostenibili.”
Notate cosa succede qui. Prima di dirci a cosa servono le supply chain, gli autori ci indicano quali aggettivi dovrebbero soddisfare: sustainable, resilient, equitable. Non viene mai esplicitato un obiettivo economico. Profitto, produttività del capitale, rendimento rettificato per il rischio — compaiono, seppure solo indirettamente. Il documento presuppone semplicemente che “efficienza” e “resilienza” coesistano accanto a un insieme di obiettivi morali preferiti, e che sia dovere della comunità OM spingere tutti questi aspetti contemporaneamente.
Nel Capitolo 4.4.5 del mio libro, “Supra‑economic goals”, utilizzo quel termine — supra‑economico — proprio per indicare questo schema: appelli a fini che presumibilmente prevalgono sulle “mere” considerazioni monetarie e giustificano, così, il superamento della disciplina dei prezzi, dei costi e dei costi opportunità. A volte il tono è moralistico (“l’azienda dovrebbe promuovere un’agenda sociale oltre al servire i clienti”); altre volte è apocalittico (“una catastrofe imminente richiede il sacrificio immediato della redditività”). In entrambi i casi, la mossa è la stessa: il calcolo economico viene silenziosamente declassato, mentre la preoccupazione preferita dall’autore viene elevata al di sopra di esso.
Il problema non è che la sostenibilità o l’equità siano poco importanti. Il problema è che la scarsità non scompare semplicemente perché le invochiamo. Ogni pallet, ogni ora uomo e ogni moneta dedicata a un obiettivo viene sottratta ad un altro. Come affermo nel libro, invocare uno scopo superiore “non dissolve la scarsità; limita solo l’etichettatura dei compromessi … non c’è alternativa a profitti e perdite.”
Se le emissioni di carbonio contano, devono essere inserite nel calcolo come costi — tramite prezzi del carbonio, regolamentazioni, comportamento dei clienti o rischio per il marchio — affinché decisioni alternative possano essere confrontate in una unità comune. Se l’equità conta, dobbiamo specificare di chi sia l’equità, a quale prezzo e con quali conseguenze, sempre in un modo che possa riflettersi nelle decisioni e essere verificato successivamente. Altrimenti, stiamo semplicemente decorando la discussione con aggettivi.
Tuttavia, il documento della visione dell’AI Era si accontenta di dichiarare che le supply chain “devono” essere sostenibili ed eque, senza mai specificare cosa significhino operativamente questi termini, chi li sostiene e a che costo. Nella sezione sanitaria, ad esempio, ci viene detto che le supply chain di consegna devono operare sotto “rigidi vincoli di sicurezza ed equità.” Dal punto di vista etico, ciò appare rassicurante; dal punto di vista della supply chain, è privo di contenuto. Quanto è “abbastanza sicuro” il “sicuro”? Equità per quali gruppi di pazienti, a quale costo in termini di produttività persa e rispetto a quali alternative? Nessun numero, nessun prezzo, nessun trade‑off.
Peggio ancora, il documento presenta questi obiettivi supra‑economici come una responsabilità della comunità OM sui bilanci altrui. È una cosa per un parlamento stabilire tasse o standard di sicurezza dopo un dibattito democratico; è tutt’altra per gli accademici dire ai manager che hanno l’obbligo di progettare supply chain “eque” senza una quantificazione esplicita di da chi e a chi vengano redistribuite. La prima è politica; la seconda, nel migliore dei casi, è paternalismo e, nel peggiore, un silenzioso invito a tradire il dovere fiduciario verso azionisti, obbligazionisti, dipendenti e clienti che potrebbero non condividere le stesse priorità.
Una volta accettato che qualsiasi causa può rivendicare una priorità supra‑economica, non esiste alcun principio limitante. Come sottolineo nel libro, la storia è disseminata di aziende che si sono allineate con entusiasmo a cause che in seguito si sono rivelate disastrose — dall’assunzione apertamente discriminatoria al sostegno caritatevole all’eugenetica — armate al tempo di un impressionante “consenso scientifico.” In ogni caso, il calcolo economico è stato subordinato alla retorica supra‑economica; in ogni caso, sono state sprecate risorse che avrebbero potuto essere impiegate per servire meglio i clienti.
Il signaling di virtù supra‑economiche non è un’ornamentazione innocua. È un fallimento etico a sé stante, perché offusca il giudizio sui compromessi mentre spende risorse che non sono degli autori da allocare. Una “visione” per la supply chain che inizia e finisce con tale signaling insegna alla prossima generazione di professionisti che dovrebbero ottimizzare per gli aggettivi piuttosto che per le conseguenze in valuta forte delle loro decisioni.
Frameworks, Livelli e l’Apparenza di Profondità
Il secondo tratto distintivo di questo documento è il suo amore per i framework e le citazioni.
Dopo l’abstract, gli autori annunciano che struttureranno la loro discussione attorno a cinque “layers” di interazione tra l’AI e il supply chain management: intelligence, execution, strategy, human e infrastructure. Ogni layer ha la sua sezione, e il resto del documento è organizzato attorno a tale classificazione.
Non c’è nulla intrinsecamente sbagliato nella tassonomia. La domanda è sempre: quali decisioni cambiano perché ora abbiamo questa specifica tassonomia anziché un’altra? Se, domani, comprimessimo i cinque layers in tre, o li dividessimo in otto, un singolo ordine di acquisto, trasferimento o prezzo sarebbe diverso? Gli autori non tentano mai di rispondere a questa domanda. Il framework agisce come un archivio per idee preesistenti; non diventa uno strumento di scelta.
I professionisti hanno già visto questo film. In Introduction to Supply Chain dedico alcune pagine a come il “planning” sia diventato lo slogan di marketing per i sistemi aziendali negli anni ‘90, anche quando contenevano ben poco più di previsioni basate sulle serie temporali e formule basilari per lo stock di sicurezza. I fornitori di ERP, seguiti da quelli di APS, hanno ribattezzato la registrazione generica dei dati come “integrated planning”, poi “advanced planning” e, più recentemente, “digital twins” e “control towers”. La terminologia è cambiata; i fogli di calcolo e i flussi di lavoro amministrativi sottostanti non lo sono stati.
L’architettura a cinque layers di questo documento sembra un altro giro di quella ruota. Crea l’impressione di profondità, ma non vi sono prove che conduca a decisioni differenti, a una migliore automazione o a un’economia migliorata. Una tassonomia che non altera ciò che accade sul pavimento del magazzino o nel ciclo di rifornimento è, dal punto di vista di un professionista, ornamento e non progresso.
Lo stesso vale per la lista delle referenze e il modo in cui viene utilizzata. Il documento sottolinea che è nato da un “esteso processo collaborativo” che ha coinvolto 42 ricercatori, professionisti e leader tecnologici, molti dei quali hanno contribuito anche al prossimo libro degli autori AI in Supply Chains: Perspectives from Global Thought Leaders. Le citazioni si concentrano fortemente su quel medesimo circolo: numerose citazioni di Cohen, Dai, Perakis e dei loro co‑autori, oltre a un gruppo di working papers recenti e articoli in stampa del team.
Ancora, non c’è nulla di illegittimo nel citare il proprio lavoro. Il problema è che la mera ampiezza della lista viene presentata come una sorta di prova in sé. Ai professionisti viene offerta una parata di titoli — “How machine learning will transform supply chain management,” “Using AI to detect panic buying,” “Large language models for supply chain optimization” — senza essere spiegato come ciascuno di questi lavori si comporti quando applicato a dati aziendali complessi, generando decisioni non controllate e venendo giudicato sulla base di profitti e perdite effettivi.
Se gestisci una rete di fabbriche e magazzini, non ti interessa quanti studi esistano su un argomento. Ciò che conta è se esista una ricetta numerica che puoi applicare ai tuoi dati, nel rispetto dei tuoi vincoli, tale da rendere gli ordini di acquisto, i trasferimenti e i prezzi di domani migliori in termini monetari rispetto a quelli di ieri. Per questo, una implementazione sul campo ben documentata, con risultati economici completi e chiari limiti, vale più di una dozzina di vision statement e cinquanta citazioni.
Il documento dell’AI Era offre il primo in forma solo superficiale e aneddotica. Una sezione su “Optimal Machine Learning” menziona due case study Fortune‑150 in cui una società di consulenza avrebbe migliorato i livelli di servizio e ridotto i costi di inventario. Al lettore non viene fornita una baseline, un controfattuale, né dettagli sul capitale totale impiegato o sul profilo di rischio prima e dopo. In altri “spotlights” del settore, ci viene detto che JD.com ha costruito un forte team di analytics e ha utilizzato l’AI per spiegare le previsioni alla direzione, o che le organizzazioni umanitarie possono usare l’AI per un migliore pre‑posizionamento delle scorte. Tutto ciò potrebbe essere vero; nulla di tutto ciò va oltre il livello di una brochure di marketing.
Dall’esterno, sembra un circuito chiuso: un cerchio di autori che si citano reciprocamente, insieme ai loro studenti, a sostegno di un framework già concordato, con di tanto in tanto qualche storia di un professionista. Per gli accademici, questo potrebbe essere il modo in cui un campo segnala attività. Per i professionisti, invece, significa che nulla di qui li aiuterà a decidere quanto acquistare la prossima settimana.
AI, Previsione e il Vecchio Equilibrio della Pianificazione
Il cuore del documento — il “layer intelligence” — è dedicato all’AI stessa. Qui, gli autori descrivono come il machine learning migliori le previsioni, come il reinforcement learning possa essere utilizzato per il controllo dell’inventario, come un paradigma emergente chiamato “decision‑focused AI” incorpori obiettivi di ottimizzazione nella funzione di loss, e come i large language models (LLMs) potrebbero fornire interfacce in linguaggio naturale e “agentic reasoning via chain‑of‑thought” per complessi problemi della supply chain.
Gran parte di ciò è tecnicamente accurato in senso stretto. Il machine learning può, infatti, incorporare molte caratteristiche; il reinforcement learning può, infatti, apprendere politiche in simulazione; gli LLM possono, infatti, interpretare e generare testi relativi a modelli di ottimizzazione. La questione non è se questi strumenti esistano; è se il loro impiego, così come presentato nel documento, affronti le reali debolezze strutturali del paradigma della pianificazione nella supply chain.
Non lo fa.
Le previsioni sono un buon esempio. Gli autori sostengono che il machine learning “migliora l’accuratezza delle previsioni” e che previsioni avanzate della domanda possano basarsi su “centinaia di variabili dinamiche provenienti sia da dataset interni che esterni.” Successivamente, nella loro discussione sull’AI decision‑focused, riconoscono che le pipeline tradizionali “predict‑then‑optimize” possono disallineare la previsione dalla decisione e propongono di addestrare i modelli direttamente sui costi decisionali a valle.
Tutto ciò procede come se il problema fondamentale delle previsioni nella supply chain fosse la mancanza di sofisticazione nei modelli di serie temporali. Non è così.
Nel libro, dedico un’intera sezione al motivo per cui il paradigma delle serie temporali è strutturalmente inadatto alle decisioni aziendali. Una serie temporale comprime la storia delle transazioni in una sequenza di numeri indicizzata per intervalli di tempo. Tale rappresentazione è soggetta a perdita in modi rilevanti. Due strutture di domanda possono produrre serie settimanali identiche di vendite — una in cui mille clienti indipendenti acquistano una unità ciascuno a settimana, e una in cui un unico grande cliente acquista tutte le mille unità. Nel primo caso, la domanda si riduce lentamente; nel secondo, può crollare da un giorno all’altro. La serie settimanale non le distingue, ma il rischio d’inventario è radicalmente diverso.
Allo stesso modo, un prodotto che vende dieci unità a settimana potrebbe consistere in dieci piccoli gruppi o in un unico grande gruppo. La serie temporale è identica; la posizione di stock sensata differisce per un fattore di quattro o più. Le previsioni basate su serie temporali, per quanto sofisticate, non possono recuperare informazioni che l’aggregazione stessa ha perso. Non si tratta di aggiungere più funzionalità o reti più profonde; la rappresentazione non corrisponde alla decisione.
Il paper non affronta mai questa critica strutturale. Presuppone semplicemente, come innumerevoli articoli prima di esso, che una migliore previsione delle serie temporali sia un collo di bottiglia centrale in supply chain e che il machine learning sia la risposta naturale. Il breve cenno alle perdite focalizzate sulle decisioni è incrementale: i modelli ora ottimizzano una funzione di perdita più rilevante, ma sono ancora addestrati sullo stesso oggetto.
Peggio ancora, quando il paper tocca specifici criteri decisionali, si affida ai soliti sospetti: service levels e inventory costs. OML viene elogiato per aver “significativamente” migliorato i service levels e ridotto gli inventory costs negli studi di caso. La domanda economica sottostante—quanto capitale dovrebbe essere impegnato per quali opzioni, sotto quale profilo di rischio—non viene mai formulata esplicitamente.
Nel libro, definisco le formule per lo safety‑stock “hazardous stocks” e noto che esse offrono un banco di prova per l’incompetenza grossolana in supply chain. Queste formule dipendono dalla scelta di un livello di servizio target—ad esempio, il 95%—e dal trattare quella percentuale come se avesse una connessione intrinseca con il profitto. Non ce l’ha. Il livello di servizio è un surrogato per un compromesso in contanti tra il dolore per l’esaurimento delle scorte e il costo del mantenimento. A meno che non si valutino entrambi i lati e si calcoli esplicitamente il compromesso, puntare al “95%” o al “97%” è numerologia. Come osservo anche io, il livello di servizio è diventato un classico KPI “fuggitivo”: un proxy che si è liberato delle sue radici economiche e ora comanda l’organizzazione, mentre nessuno è costretto a indicare prezzi reali.
Il paper AI Era non mette mai in discussione questa cultura dei KPI; incorpora l’AI al suo interno. Le previsioni vengono migliorate; le politiche di inventory possono essere adattate; i service levels diventano leggermente più elevati e l’inventario un po’ più contenuto—e ci viene detto che questo è progresso. Non si fa menzione di tassi di rendimento aggiustati per il rischio, di come le opzioni siano valutate rispetto a un vincolo sul capitale circolante, o di come le prestazioni del modello siano giudicate al confine in cui le raccomandazioni vengono reinserite nell’ERP e il denaro effettivamente si muove.
Il trattamento dei large language models è un altro esempio. Il paper suggerisce che gli LLMs “promettono di rendere gli strumenti di pianificazione avanzata più accessibili” e possono fornire interfacce in linguaggio naturale che “democratizzano l’accesso agli strumenti decisionali avanzati.”
Nel libro, sostengo che i language models generalmente consumano ordini di grandezza in più di computazione rispetto ad algoritmi specializzati che svolgono lo stesso compito e che è improbabile siano competitivi per l’elaborazione di dati numerici. Il loro ruolo legittimo in supply chain è limitato: accelerare la scrittura e la manutenzione di ricette numeriche e documentazione, ed estrarre caratteristiche da testo non strutturato. Utilizzarli come motori di previsione è esplicitamente fuorviante: sono “mal adatti alla previsione di serie temporali—o a qualsiasi tipo di lavoro numerico” e performano in modo scarso, a costi elevati, rispetto ai modelli statistici di base.
Il vision paper, ancora una volta, s’inoltra nella moda: gli LLMs diventano risolutori di problemi “agentic” che possono aiutare ad ottimizzare le politiche di reinforcement-learning e ragionare, mediante chain‑of‑thought, su complesse decisioni in supply chain. Non c’è una discussione seria sull’affidabilità numerica, sui costi, o sul punto fondamentale che i generatori di testo stocastici costituiscono una base molto debole per impegni non supervisionati che coinvolgono milioni di dollari di inventario.
Spogliato del suo alone AI, ciò che il paper offre è lo stesso equilibrio di pianificazione che ha dominato per decenni: previsioni come serie temporali, piani come insiemi di serie temporali, livelli di servizio come talismani, e umani a convalidare i risultati. L’AI è invitata a posizionarsi in cima a questa struttura come potenziatore, non per sfidare le sue premesse.
Perché i professionisti distolgono (e dovrebbero) lo sguardo
Tutto ciò non avrebbe molta importanza se il paper fosse semplicemente un esercizio accademico. Ma è esplicitamente concepito come una guida per professionisti ed educatori. I suoi autori concludono con appelli a ricercatori, leader dell’industria e università, invitandoli a costruire curricula incentrati sulla collaborazione uomo–AI, a sviluppare quadri di governance per implementazioni di AI “etica” e a progettare supply chain che aumentino la “resilienza, la produttività e il benessere sociale.”
La difficoltà è che il modello mentale sottostante non lascia mai il comfort della sala seminari.
Non si insiste affinché le tecniche vengano testate su dati aziendali completi e disordinati, generando decisioni non supervisionate e venendo giudicate rispetto a un parametro denominato in denaro. Non si insiste affinché le preoccupazioni supra‑economiche vengano tradotte in prezzi, regolamenti o rischi quantificabili prima che possano prevalere sul profitto. Non si insiste affinché i quadri siano giustificati dai cambiamenti concreti che inducono nelle emissioni—ciò che viene acquistato, trasportato e prezzato—e non dal numero di diapositive che riescono a riempire.
Nel Capitolo 6.2 del mio libro, discutendo dell’intelligenza generale e del ruolo del software in supply chain, sottolineo che molti modelli pubblicati trattano le scelte progettuali cruciali—obiettivo, vincoli, opzioni ammissibili—as implicit. Operano all’interno di enigmi ordinati e delimitati, lasciando la parte disordinata, quella per cui gli imprenditori vengono effettivamente pagati, fuori scena. Il rimedio è concettualmente semplice, sebbene difficile nella pratica: enunciare l’obiettivo economico in termini monetari, enumerare le opzioni ammissibili, definire le condizioni di arresto, e quindi scomporre il lavoro in sottoproblemi delimitati che le macchine possono risolvere.
La dichiarazione visionaria AI Era non lo fa. Parte da aggettivi non prezzati, accumula una classificazione, esamina una letteratura per lo più scritta dai suoi stessi autori e dai loro pari, e poi invoca ulteriori elementi simili sotto l’egida dell’AI. È eloquente, sincera e, per chiunque tenti di gestire una supply chain, quasi completamente fuori luogo.
È per questo che i professionisti ignorano questo tipo di lavoro. Non perché siano anti-intellettuali, ma perché hanno imparato, spesso a caro prezzo, che quadri senza funzioni obiettivo, previsioni senza una discussione onesta dei limiti della rappresentazione, AI senza un metro economico, ed etica senza prezzi convergono tutte nello stesso punto: presentazioni diapositive impressionanti, progetti pilota modesti e nessun incremento duraturo del tasso di ritorno dell’impresa.
Se l’accademia vuole tornare ad avere peso in supply chain, dovrà invertire il modello illustrato così chiaramente da questo paper. Parti dall’economia, non dagli aggettivi. Trasforma le preoccupazioni—ambientali, sociali o di altro genere—in compromessi espliciti, anziché in slogan morali. Valuta i modelli in base alle loro prestazioni su dati disordinati, sotto vincoli reali, con decisioni non supervisionate e denaro in gioco. Accetta che la pianificazione delle serie temporali sia, per molti problemi, una strada senza uscita, e che l’AI non rappresenti un fertilizzante magico per un paradigma difettoso.
Fino ad allora, i professionisti non sono solo giustificati nell’ignorare tali dichiarazioni visionarie. Stanno agendo con prudenza.


