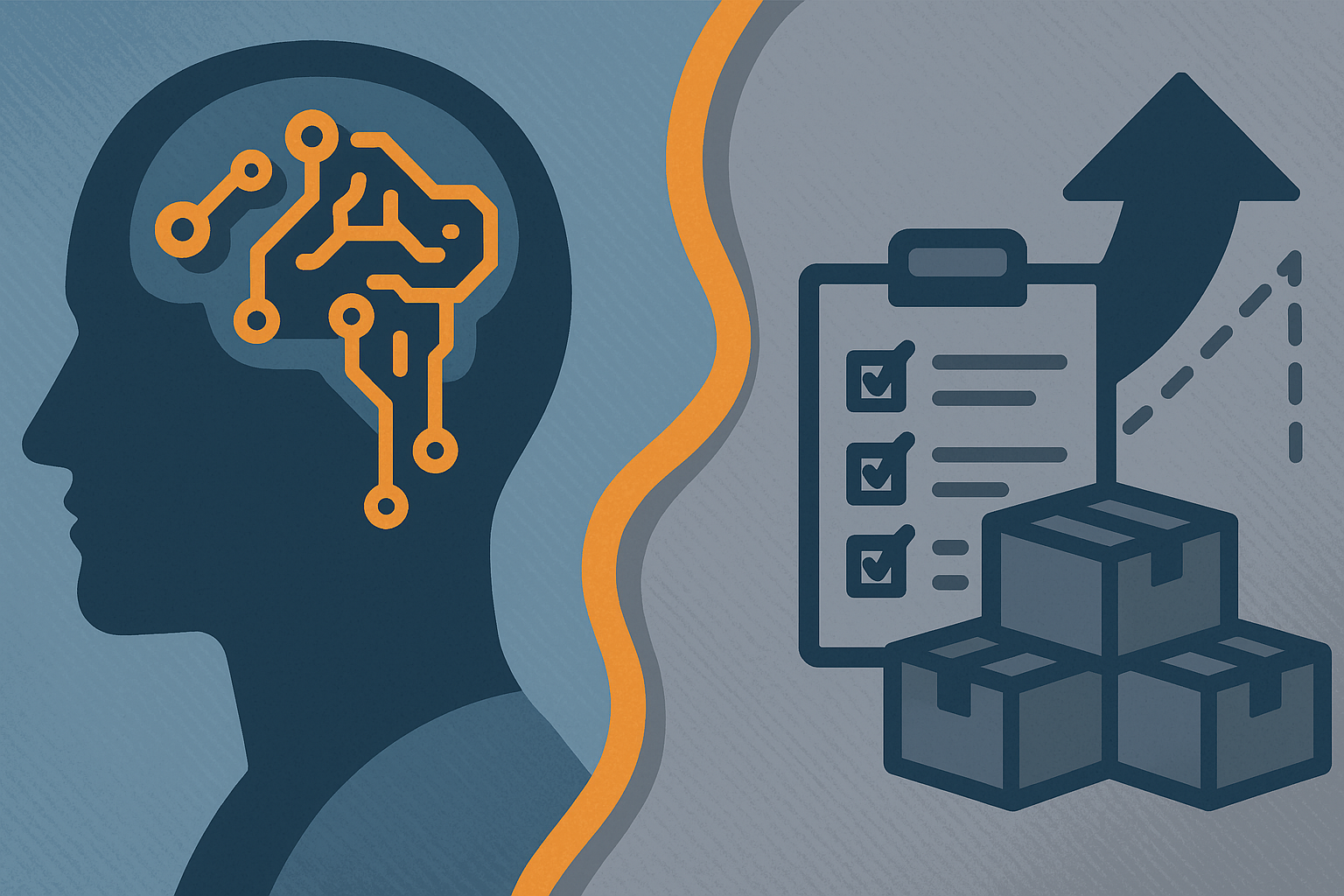Supply Chain come scommesse economiche in un mondo guidato dal mercato
Negli ultimi due decenni, ho osservato come il “supply chain management” accumuli buzzwords più velocemente dei risultati. Parliamo di digital twins, control towers, integrated business planning, demand sensing, resilienza, sostenibilità. Eppure, se si esaminano attentamente bilanci e conti economici, molte aziende non hanno fatto molti progressi in termini di come trasformano il capitale circolante, la capacità e la complessità in ritorni economici.
Tra le voci che cercano di dare un senso a questa stagnazione, alcuni hanno sostenuto reti di valore guidate dal mercato e approcci outside-in, dedicando notevoli sforzi a misurare le performance su lunghi periodi. Il mio lavoro esamina la stessa realtà economica da un diverso punto di vista. Lo scopo di questo saggio è chiarire tale prospettiva.

Nel mio libro Introduction to Supply Chain, in particolare nei capitoli iniziali, ho cercato di riformulare il supply chain management come una disciplina economica rigorosa, focalizzata su come le aziende allocano risorse scarse in condizioni di incertezza. Il libro approfondisce più di quanto io possa fare qui, ma l’idea centrale è semplice: ogni volta che decidiamo cosa acquistare, produrre, spostare o prezzare, stiamo piazzando piccole scommesse economiche con esiti incerti. Una moderna supply chain dovrebbe essere giudicata dalla qualità di queste scommesse e dalle conseguenze finanziarie a lungo termine che esse generano.
Una linea di lavoro influente parte da una prospettiva diversa. Esamina serie storiche di metriche finanziarie tra gruppi di pari e si chiede: quali aziende hanno realmente migliorato la loro posizione in termini di crescita, margine, rotazione dell’inventario e utilizzo degli asset? Alcuni definiscono questo come una “frontiera efficace.” Trovo utile questa prospettiva. La nostra divergenza risiede meno nell’obiettivo e più nel meccanismo che riteniamo possa condurci a tale risultato.
Due punti di vista sullo stesso problema
Una descrizione comune presenta le supply chain come reti di valore guidate dal mercato. L’enfasi è sul percepire i mercati, con un approccio outside-in. Invece di trattare gli ordini provenienti dal nodo successivo della catena come “domanda”, l’argomento è che dobbiamo interpretare il mercato reale: dati di vendita al dettaglio, inventario dei canali, promozioni, segnali sociali, vincoli dei fornitori, shock macroeconomici. La supply chain è quindi un insieme di processi collegati che trasformano questi segnali in risposte coordinate: pianificazione, approvvigionamento, produzione, consegna.
La mia prospettiva appare più ristretta, ma è tagliente per design. Mi concentro sul momento della decisione. Dovremmo acquistare un’unità in più di questo articolo per quel magazzino, da ricevere in quella data? Dovremmo anticipare la produzione di questo lotto, ritardarla o annullarla? Dovremmo abbassare il prezzo di questo SKU per questo canale domani, o mantenerlo invariato? Ciascuna di queste decisioni consuma qualcosa di scarso: liquidità, capacità, spazio sugli scaffali, attenzione umana, fiducia da parte dei clienti o dei fornitori. Inoltre, essa crea esposizione a una gamma di futuri possibili.
Da questa prospettiva, una supply chain è una macchina che trasforma l’incertezza in decisioni, e le decisioni in risultati finanziari. Sono meno interessato all’eleganza del diagramma dei processi e più interessato alla qualità della decisione successiva e di quella che segue, su larga scala.
Il punto di vista outside-in osserva il panorama da 10.000 metri: come l’azienda si muove rispetto ai concorrenti su una frontiera di performance multi-dimensionale. Io mi posiziono più vicino al suolo e mi chiedo se i milioni di piccole scommesse che compongono le operazioni quotidiane abbiano senso economico, data l’incertezza che effettivamente affrontiamo. Queste prospettive non sono contraddittorie. Esse si limitano a ingrandire diversi livelli dello stesso sistema.
Cosa stiamo cercando di ottimizzare esattamente?
Se eliminiamo il gergo, queste diverse prospettive parlano tutte di performance. Ma scelgono lenti differenti per definirla.
Una lente è esplicitamente comparativa e pluriennale. Essa si preoccupa di come un’azienda performa rispetto ai suoi concorrenti diretti in termini di crescita dei ricavi, margine operativo, rotazione dell’inventario e, talvolta, cicli cash-to-cash o utilizzo degli asset. Un’azienda che cresce rapidamente ma sacrifica il margine non è eccellente. Un’azienda che riduce il suo inventario ma anche la sua quota di mercato non è eccellente. L’eccellenza risiede su una frontiera efficace in cui questi parametri sono migliorati congiuntamente o almeno ben bilanciati.
La mia lente è basata sull’unità e marginale. Mi concentro sul rendimento aggiustato per il rischio della decisione marginale. Se acquisto un’unità in più del prodotto X da collocare nella località Y per la settimana Z, dato ciò che so ora, qual è il rendimento finanziario atteso? Quanto profitto porta in media questa unità aggiuntiva, considerando la possibilità che venga venduta in tempo, la possibilità che venga venduta in ritardo a prezzo scontato, o la possibilità che non venga venduta affatto e diventi obsoleta? Come si confronta questo con l’investimento di quella stessa unità di capitale circolante in un altro prodotto, in un’altra località, o semplicemente nel non investirla?
Per ragionare su questo, abbiamo bisogno di una scala comune. Il denaro non è tutto, ma è l’unità con cui l’azienda estingue i propri impegni e misura la propria sopravvivenza. Perciò insisto nel tradurre tutti i compromessi che intasano le discussioni sul supply chain in termini finanziari coerenti. Una carenza non è “cattiva” in astratto; essa comporta costi in termini di margine perso, mancato afflusso di affari futuri e danni alla reputazione. Un eccesso di stock non è semplicemente “spreco”; è un’opzione che potrebbe comunque ripagarsi, o potrebbe marcire. Una capacità che appare inattiva su un cruscotto potrebbe essere preziosa come cuscinetto contro una volatilità che non è ancora presente nei dati storici.
La frontiera efficace e il rendimento marginale aggiustato per il rischio sono due modi di parlare dello stesso fenomeno sottostante. Un punto di vista guarda all’integrale: la traiettoria pluriennale a lungo termine dell’azienda. Io guardo alla derivata: l’effetto incrementale della decisione successiva. In pratica, non è possibile avere un buon integrale con una cattiva derivata per molto tempo. L’eccellenza persistente sulla frontiera richiede in definitiva che le decisioni quotidiane, su migliaia di articoli e località, siano economicamente sensate data l’incertezza.
Previsioni, piani e l’illusione della certezza
Alcuni dei critici più persistenti del pensiero “inside-out” hanno osservato che le aziende trattano i propri ordini e le spedizioni storiche come se fossero una rappresentazione fedele della domanda. Questa visione è sia tardiva che parziale. Gli ordini sono influenzati da promozioni, regole di allocazione, esaurimenti di stock a monte, scarsa integrazione dei dati e una serie di altre distorsioni. In quell’ottica alternativa, una moderna supply chain dovrebbe essere “outside-in”: partire dai segnali reali di mercato e di offerta, per poi orchestrare la risposta.
Condivido la critica alla pianificazione inside-out, ma la affronto da un punto di vista probabilistico. Le previsioni, così come sono comunemente praticate, impongono un’illusione rassicurante di certezza. Prendiamo un futuro caotico e incerto e lo comprimiamo in un unico numero: la “domanda attesa” per un determinato periodo. Costruiamo poi scorte di sicurezza e piani deterministici attorno a quel numero, come se l’errore fosse solo un fastidio marginale anziché l’evento principale.
Questo modo di operare scarta proprio l’informazione di cui abbiamo più bisogno: la gamma dei futuri plausibili e le loro probabilità. Nel mio lavoro sostengo che le previsioni dovrebbero essere distribuzioni, non punti. La domanda non è “Qual è la previsione di vendita per il prossimo mese?” ma “Come appare la distribuzione di probabilità delle vendite possibili?” Quali sono le probabilità di non vendere nulla? Di vendere il doppio del volume abituale? Come appaiono le code della distribuzione?
Una volta ottenute tali distribuzioni, il piano cessa di essere un singolo “numero di consenso” negoziato nelle riunioni e diventa una serie di decisioni calcolate da algoritmi che ponderano costi e opportunità in base a quelle distribuzioni. La stessa distribuzione della domanda può giustificare decisioni molto diverse in termini di inventario o produzione, a seconda delle conseguenze finanziarie degli esaurimenti rispetto all’eccesso, dei tempi di consegna coinvolti e della disponibilità di sostituti.
Anche qui, queste critiche reagiscono contro lo stesso fallimento: fingere che un comportamento incerto e non lineare possa essere catturato in una singola colonna di un foglio di calcolo. Un filone di pensiero sostiene la necessità di segnali più ricchi e precoci e di riprogettazioni dei processi che spostino la pianificazione in una prospettiva outside-in. Io invece insisto su modelli probabilistici che ci costringano a confrontarci esplicitamente con l’incertezza e su sistemi decisionali in grado di elaborare tali modelli su larga scala.
In una pratica sana, queste due preoccupazioni dovrebbero convergere. Si desiderano segnali di qualità e una rappresentazione realistica dell’incertezza; flussi outside-in che alimentano decisioni probabilistiche e economicamente fondate.
Tecnologia: architettura versus motore
Molti osservatori sottolineano le limitazioni dello stack tecnologico che la maggior parte delle aziende ha ereditato. Questi stack sono stati costruiti principalmente per l’efficienza transazionale: registrare ordini, spedizioni, fatture e così via. Integrano dati tra le funzioni, ma non necessariamente aiutano le aziende a prendere decisioni migliori. Il rimedio usuale proposto è riprogettare l’architettura intorno ai flussi di informazione sulla domanda e l’offerta: livelli di dati esterni, tassonomie migliori, visibilità dell’inventario quasi in tempo reale e strumenti analitici più flessibili.
Concordo che lo stack ereditato sia una grande parte del problema. Tuttavia, pongo l’enfasi altrove. La capacità fondamentale mancante, a mio avviso, non è un ulteriore strato di integrazione o un altro cruscotto, ma un motore decisionale.
Con ciò intendo un software che, ogni giorno, acquisisca tutti i dati rilevanti, tutti i vincoli attuali e un insieme di valutazioni economiche, per poi proporre o emettere direttamente decisioni concrete: quali ordini di acquisto effettuare, quali ordini di produzione pianificare, quali trasferimenti eseguire, quali prezzi regolare. Questo motore deve essere programmabile, verificabile e sufficientemente veloce da gestire milioni di tali decisioni in un tempo ragionevole. Deve inoltre essere in grado di spiegare, a posteriori, perché è stata presa una particolare decisione, dati i dati e le valutazioni al momento.
Le architetture in stile outside-in sono utili perché forniscono input migliori a tale motore. Ma senza il motore, rischiano di trasformarsi in sistemi di reporting più sofisticati. Vedrete il problema in modo più chiaro, a più colori e con più metriche di latenza, ma continuerete a dipendere da eserciti di pianificatori che muovono numeri in fogli di calcolo, cercando di riconciliare manualmente obiettivi contrastanti.
Non è controverso sostenere che la tecnologia debba servire a una migliore modellazione e a decisioni migliori, non solo a una migliore integrazione. Un’enfasi sull’architettura evidenzia dove i dati dovrebbero fluire e come i processi dovrebbero essere organizzati. La mia enfasi sul motore sottolinea ciò che alla fine deve accadere con quei dati: un gran numero di decisioni economicamente sensate in condizioni di incertezza. Queste sono preoccupazioni complementari, ma personalmente metterei il motore al centro, con l’architettura al suo servizio.
Organizzazione, governance e il ruolo di S&OP
Molti testi contemporanei ruotano attorno al sales and operations planning e alla sua evoluzione. Esistono modelli di maturità in cui l’S&OP passa da semplici verifiche di fattibilità a una pianificazione incentrata sul profitto, poi a un orientamento demand-driven e infine a un’orchestrazione market-driven. In queste narrazioni, l’S&OP è il principale processo orizzontale che attraversa i silos e allinea le funzioni. È il luogo in cui vengono negoziati i compromessi e in cui viene portata in tavola la prospettiva outside-in.
Condivido la diagnosi secondo cui i silos sono una fonte importante di distruzione del valore. Quando ogni funzione ottimizza i propri indicatori — il livello di servizio qui, l’utilizzo lì, l’accuratezza delle previsioni altrove — l’intero sistema ne risente. Le persone dedicano enormi sforzi a risolvere conflitti tra piani che non sono mai stati concepiti per essere compatibili.
Dove mi divergo è riguardo a quanto centrale debba rimanere l’S&OP, inteso come riunione di pianificazione, a lungo termine. A mio avviso, se facciamo bene il nostro lavoro dal lato tecnologico, la maggior parte della pianificazione operativa dovrebbe essere delegata al motore decisionale descritto in precedenza. Questo motore viene alimentato dai dati più aggiornati e dalle attuali valutazioni economiche (ad esempio, il costo relativo dell’esaurimento rispetto all’eccesso per un determinato articolo, o il valore di un giorno di riduzione dei tempi di consegna per una determinata tratta). Ricalcola le decisioni ottimali man mano che le condizioni cambiano, molto più frequentemente e in modo più coerente di quanto possa fare qualsiasi processo umano.
Ciò che rimane per l’S&OP o l’integrated business planning è la governance piuttosto che la pianificazione. Invece di trascorrere il tempo a modificare le quantità in un foglio di calcolo, i dirigenti dovrebbero dedicarsi ad aggiustare le regole del gioco: le valutazioni finanziarie, i vincoli, l’appetito per il rischio. Dovrebbero esaminare come le decisioni del motore si traducono in risultati realizzati e utilizzare questo feedback per perfezionare i parametri economici e le assunzioni strutturali.
Si tratta di un cambiamento sottile ma profondo. Trasforma l’S&OP da un tentativo collettivo di realizzare a mano un unico piano “corretto” in una revisione periodica di quanto bene un sistema decisionale automatizzato stia performando, in base agli obiettivi dell’azienda. L’attenzione umana passa dalla microgestione delle quantità alla calibrazione degli incentivi e dei vincoli.
I modelli di maturità di questo tipo possono ancora essere utili in questo contesto, in particolare come strumento diagnostico per comprendere la posizione culturale e organizzativa di un’azienda. Tuttavia, sostengo che lo stato finale non riguardi tanto riunioni di pianificazione più sofisticate quanto una governance economica migliore dei sistemi decisionali automatizzati.
Come sappiamo ciò che sappiamo?
Il campo della supply chain è scomodo da un punto di vista epistemologico. Gli esperimenti sono costosi, gli ambienti sono rumorosi e il numero di variabili è scoraggiante. È facile confondere storie plausibili con una conoscenza solida.
Alcuni ricercatori, ad esempio Lora Cecere, hanno investito notevoli sforzi per fondare le loro opinioni sui dati finanziari. Invece di fare affidamento su sondaggi auto-riferiti o aneddoti di consulenza, hanno ricostruito le storie delle performance delle aziende utilizzando i bilanci finanziari pubblici e cercato modelli nel tempo. Questo non dimostra la causalità, ma impone una disciplina: le pratiche che celebriamo come “le migliori” dovrebbero almeno correlarsi con miglioramenti a lungo termine in termini di crescita, margini e rotazione dell’inventario.
La mia espressione di scetticismo assume una forma diversa. Mi preoccupa la sopravvivenza di tecniche la cui principale virtù un tempo era la convenienza computazionale—formule di safety stock basate su assunzioni eroiche, modelli linearizzati di fenomeni chiaramente non lineari, gerarchie di pianificazione semplificate che riflettono più organigrammi che realtà economica. Molti di questi artefatti sono persistiti perché erano facili da calcolare su carta o con i primi computer. Oggi disponiamo di una potenza computazionale ben superiore, eppure vi siamo ancora aggrappati.
Mi preoccupo anche delle strutture degli incentivi. I fornitori di software, i consulenti, gli accademici e gli stakeholder interni hanno tutti motivi per preferire narrazioni che giustificano grandi progetti, framework complessi o aggiustamenti incrementali. Esiste un incentivo comparativamente esiguo a dimostrare che un metodo tanto caro sta sistematicamente perdendo denaro in pratica.
La risposta, a mio avviso, è quella di avvicinare supply chain all’economia applicata con una forte componente empirica e computazionale. Dovremmo formulare esplicitamente le nostre assunzioni, codificarle in algoritmi e confrontarle con la realtà attraverso i risultati finanziari della stessa azienda. Quando una politica distrugge sistematicamente il valore in un determinato contesto, dovremmo abbandonarla, indipendentemente da quanto possa essere elegante o ampiamente insegnata.
Su questo punto, queste prospettive convergono. Vi è un rifiuto condiviso dell’idea che esistano delle “best practices” senza tempo in attesa di essere implementate. Esistono solo pratiche che funzionano nel contesto, per un certo periodo, fino a quando l’ambiente o il panorama competitivo non cambiano.
Verso una sintesi
Se sei un dirigente o un professionista che cerca di orientarsi in queste idee, potrebbe essere utile pensare in termini di livelli.
Il lavoro outside-in, finanziariamente fondato, è inestimabile al livello strategico e diagnostico. Ti aiuta a porre le domande giuste: dove ci troviamo sulla frontiera efficace rispetto ai nostri pari? Stiamo crescendo, siamo redditizi e efficienti in termini di capitale, oppure stiamo scambiando una dimensione con l’altra? I nostri processi rimangono inside-out, dominati dall’inerzia delle transazioni ERP e dei silos funzionali, o ci siamo veramente mossi verso flussi market-driven, outside-in?
Il mio lavoro personale è più focalizzato sul livello operativo e computazionale. Voglio che tu sia in grado di rispondere a domande come: dato il nostro attuale livello di comprensione dell’incertezza nella domanda e nell’offerta, e date le nostre valutazioni finanziarie, le decisioni che prendiamo ogni giorno stanno davvero massimizzando il nostro ritorno corretto per il rischio sulle risorse scarse? Possiamo prendere quelle decisioni in modo coerente e su larga scala attraverso il software, piuttosto che manualmente, mantenendo la capacità di verificare e migliorare la logica sottostante?
Questi livelli non sono alternativi. In un mondo ideale, un’azienda utilizzerebbe la lente strategica per definire come appare l’eccellenza e per misurare i progressi nel corso degli anni, utilizzando al contempo un motore decisionale economico e probabilistico per guidare le operazioni quotidiane verso quell’obiettivo. L’architettura outside-in alimenterebbe il motore con segnali ricchi e tempestivi. I forum di governance si concentrerebbero sulla calibrazione dei parametri economici piuttosto che sull’editing delle quantità. E il concetto di “best practice” verrebbe sostituito da un approccio più umile ed empirico: ciò che funziona, qui e ora, in questa specifica rete, come evidenziato dai risultati finanziari effettivi.
In tal senso, ogni apparente scontro tra queste visioni non è un conflitto tra teorie incompatibili. È una conversazione su dove porre l’enfasi: sull’architettura e il processo, oppure sugli algoritmi e l’economia; sulle traiettorie a lungo termine, o sulle decisioni marginali. Entrambe le prospettive sono necessarie. Ma se dovessi riassumere la mia posizione in una frase, sarebbe questa:
Supply chain è, nel suo nucleo, una disciplina economica che dovrebbe essere praticata attraverso il software come l’arte di fare buone scommesse in condizioni di incertezza.
Tutto il resto—processi, architetture, dashboard, persino i modelli di maturità—dovrebbe essere valutato in funzione del grado in cui aiuta o ostacola tale compito centrale.