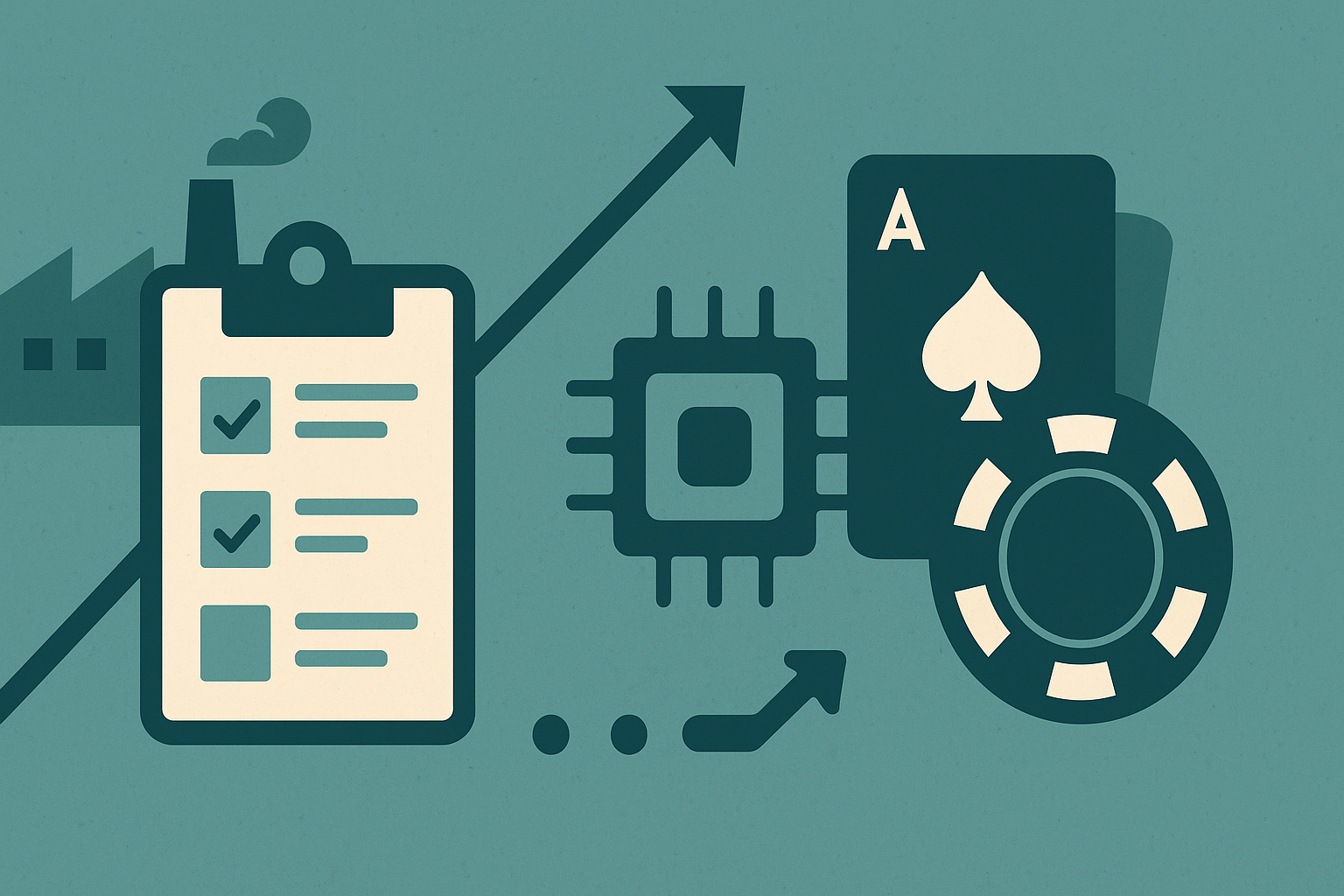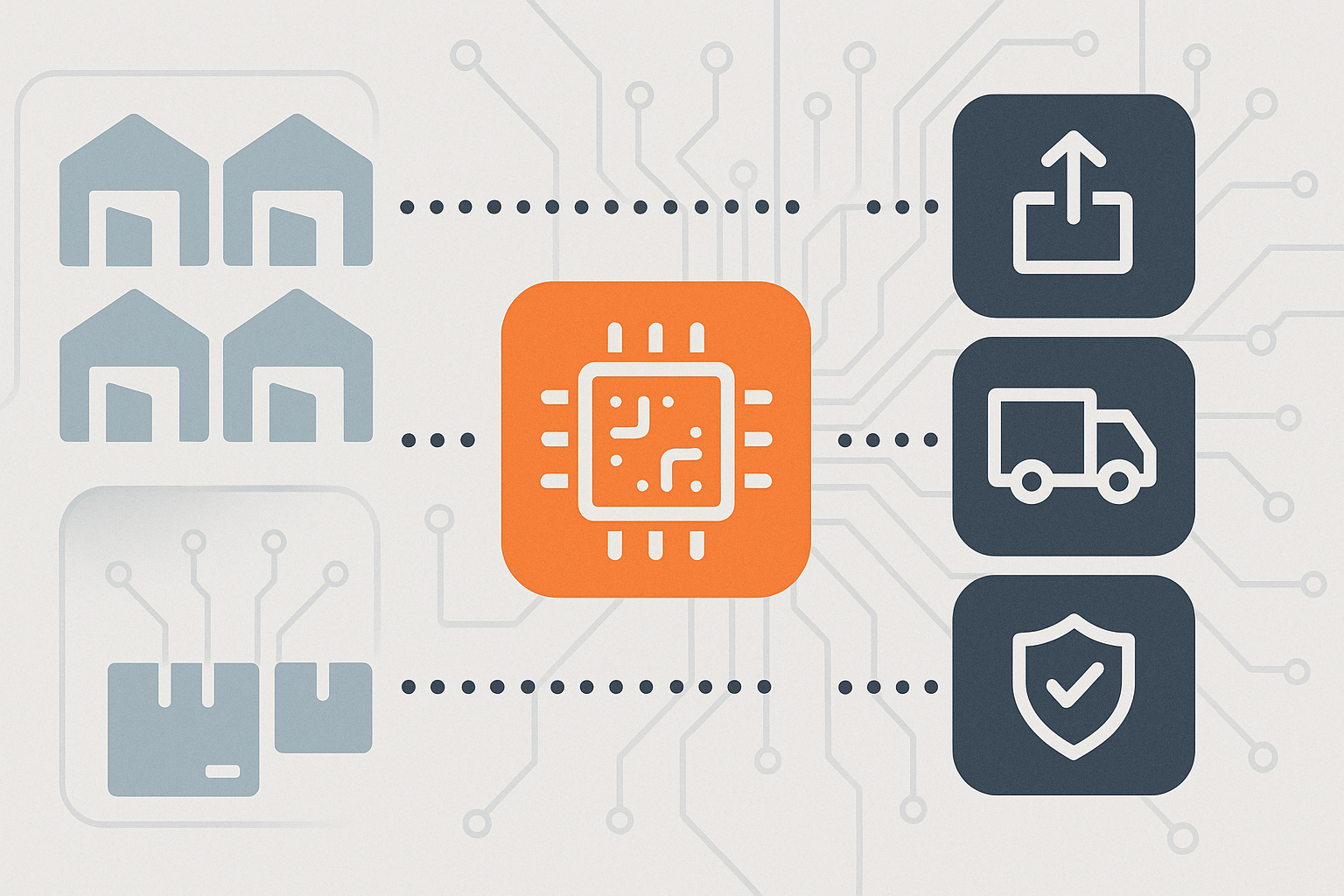Supply Chain come Economia Applicata: Perché “non contrario al profitto” non è sufficiente
Per la maggior parte delle aziende, la “supply chain” viene introdotta come una miscela di logistica, processi di pianificazione e software. Parliamo di magazzini, tempi di consegna, previsioni, meeting S&OP, dashboard e schede di valutazione dei fornitori. La promessa implicita è che, se orchestriamo bene questi elementi, l’azienda sarà in salute.
Eppure, quando osservo come la supply chain viene solitamente insegnata e praticata, noto una notevole omissione. Il campo stesso che trascorre le sue giornate ad allocare capacità produttiva, spazio per il trasporto, capitale circolante e attenzione gestionale, raramente si descrive per quello che realmente è: economia applicata.
Esploro questo argomento nel mio libro Introduction to Supply Chain, disponibile integralmente online, ma l’idea centrale è abbastanza semplice da presentare da sola.
In questo saggio voglio chiarire cosa intendo per “supply chain come economia applicata” e confrontarlo direttamente con la visione dominante.
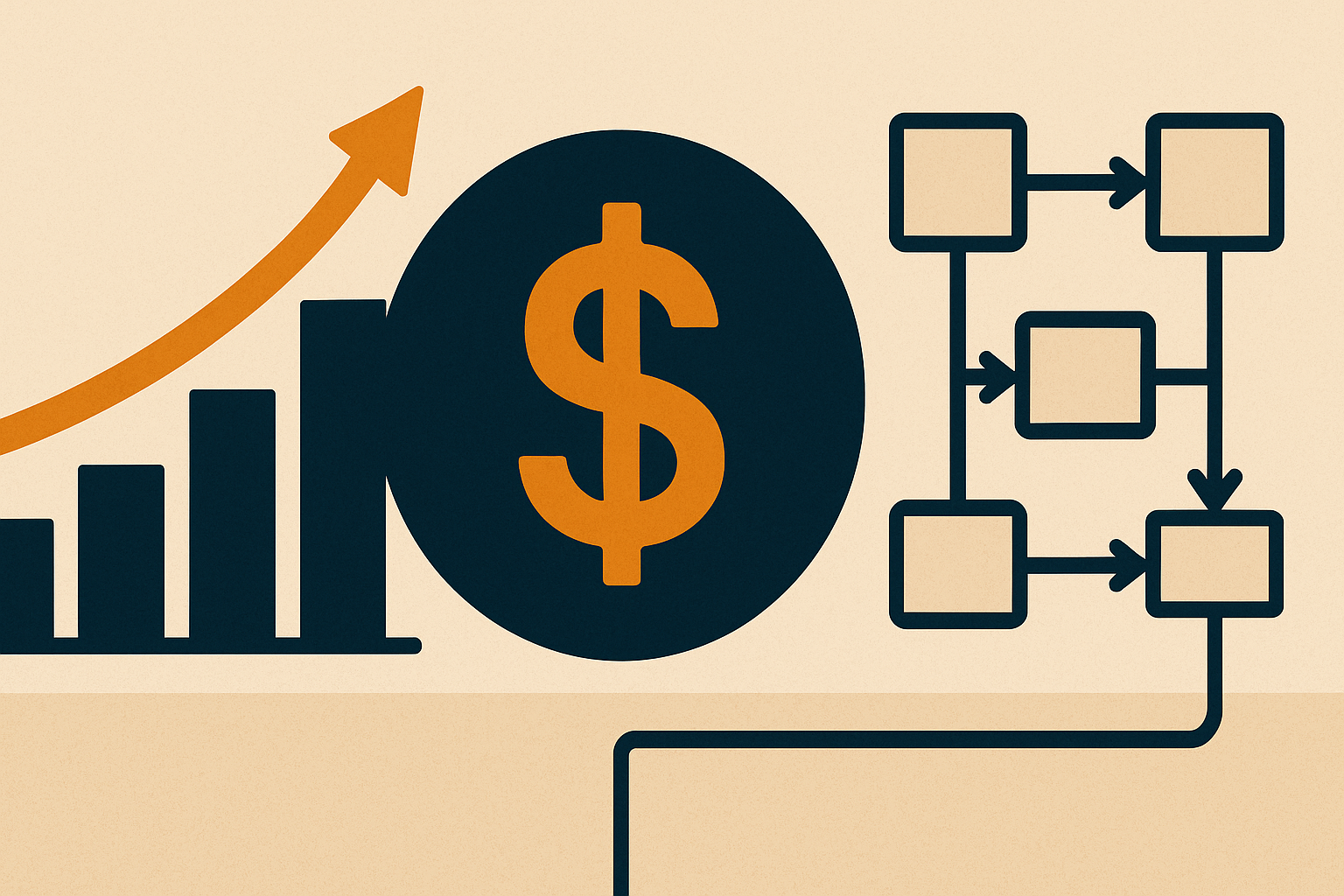
Partire da Robbins, non dagli organigrammi
Inizio con Lionel Robbins, non con i magazzini.
Nel suo saggio classico sulla scienza economica, Robbins propose quella che è diventata la definizione canonica: l’economia è “la scienza che studia il comportamento umano come relazione tra fini e mezzi scarsi che hanno usi alternativi.”
Eliminando la formulazione più arcaica, il suo punto di vista risulta molto moderno:
- Desideriamo sempre più di quanto possiamo avere.
- I mezzi a nostra disposizione—tempo, denaro, capacità, buona volontà—possono essere utilizzati in modi diversi.
- Ogni scelta su come utilizzare tali mezzi implica implicitamente il rifiuto di altre possibilità.
L’economia, in questa visione, non riguarda un ambito specifico come i mercati o i governi. Riguarda un aspetto specifico del comportamento: come affrontiamo i compromessi quando ciò che desideriamo supera ciò che possiamo realizzare.
Visto da questo punto di vista, una supply chain non è principalmente una rete di fabbriche e camion. È una fitta rete di compromessi: Questo pallet dovrebbe andare al negozio A o al negozio B? Dovremmo tenere questa linea inattiva per manutenzione o accelerare un ordine urgente in più? Dovremmo acquistare più scorte in vista di una promozione o mantenere liquidità libera per il lancio di un nuovo prodotto?
Ognuna di queste domande è un problema economico in stile Robbins. I mezzi sono scarsi. Gli usi sono alternativi. Le conseguenze sono mutuamente esclusive.
Se accetti questo punto di partenza, la supply chain smette di essere una sottocategoria delle “operations” e diventa un ramo specifico dell’economia applicata focalizzato sui flussi fisici in condizioni di incertezza.
Come il mainstream definisce la supply chain
Ora confronta questo con il modo in cui la supply chain viene solitamente definita nei circoli professionali.
Il Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), uno dei principali organismi di riferimento nel campo, descrive il supply chain management come comprendente la pianificazione e la gestione dell’approvvigionamento e della fornitura, della conversione e di tutta la logistica, insieme al coordinamento e alla collaborazione con i partner. A loro dire, integra la gestione dell’offerta e della domanda all’interno e tra le aziende.
Questa è una descrizione perfettamente ragionevole di cosa tocca la supply chain: fornitori, fabbriche, magazzini, trasporti, clienti e le informazioni che li collegano. È simile a come iniziano molti libri di testo: la supply chain è la gestione dei flussi di prodotti, informazioni e fondi attraverso le fasi che vanno dalla materia prima al cliente finale.
Alcuni autori vanno oltre ed introducono l’idea del “supply chain surplus,” definito approssimativamente come il valore del prodotto per il cliente meno il costo totale della supply chain. L’obiettivo dichiarato è massimizzare questo surplus.
Nulla di tutto ciò è sbagliato. Ma nota cosa manca.
Ci viene detto quali attività sono comprese nell’ambito. Ci viene detto che il valore e il costo sono importanti, e che la supply chain dovrebbe in qualche modo supportare la competitività. Eppure, le definizioni restano in silenzio sulla questione economica centrale: in base a quale criterio dovremmo scegliere tra due modi fattibili di gestire la catena?
“Più surplus” può sembrare un criterio a prima vista, ma in pratica viene raramente calcolato come un numero concreto basato sui flussi di cassa e sull’incertezza. Si comporta più come uno slogan: “fare cose che riteniamo saranno vantaggiose per i clienti e più economiche da fornire.” Il legame con il profitto è presunto, non esplicitato.
È qui che la mia visione si discosta nettamente dal mainstream.
Perché “non contrario al profitto” non è sufficiente
Se chiedi ai professionisti del mainstream se sono contrari al profitto, ovviamente risponderanno di no. Molti diranno addirittura che migliorare il profitto è uno dei loro obiettivi.
Ma ascolta come le idee vengono tipicamente giustificate.
Un nuovo metodo di inventario è “buono” perché promette livelli di servizio più alti e minori scorte. Un nuovo processo di pianificazione è “buono” perché migliora la collaborazione e la visibilità. Un nuovo KPI è “buono” perché riflette una best practice. La catena di ragionamento implicita è sempre la stessa: queste cose sembrano dover aiutare l’azienda, quindi devono farlo.
In termini di Robbins, si tratta di un errore di categoria. L’essenza stessa dell’economia è che non possiamo affidarci all’intuizione sui compromessi. Quando i mezzi sono scarsi e le alternative molteplici, quasi ogni cambiamento aiuta una dimensione e danneggia un’altra.
Un livello di servizio più elevato potrebbe essere positivo per le vendite e terribile per il capitale circolante. Un inventario più snello potrebbe ridurre i costi di mantenimento e aumentare le vendite perse in un modo che resta invisibile fino al prossimo picco di domanda. Un processo di pianificazione più complesso potrebbe migliorare il consenso, pur sprecando il tempo dei decisori, che sono scarsi.
Se non ci costringiamo mai a esprimere questi effetti in termini economici comparabili, “buono per l’azienda” diventa una storia, non un’affermazione verificabile.
Affermare “il nostro campo non è contrario al profitto” non è quindi sufficiente. La domanda è se il profitto—inteso in senso rigoroso, consapevole del rischio e a lungo termine—sia esplicitamente integrato nei nostri metodi come obiettivo organizzativo.
Supply chain come economia applicata: cosa intendo realmente
Quando dico che la supply chain è economia applicata, non intendo semplicemente dire “i numeri contano” o “dovremmo pensare a costi e prezzi.”
Intendo qualcosa di più preciso.
Innanzitutto, la materia prima della pratica della supply chain non sono i dati o i processi. È la scarsità con alternative. Le scorte, la capacità, il capitale, la buona volontà del fornitore, l’attenzione del cliente e persino le autorizzazioni normative sono tutti mezzi scarsi con diversi usi possibili. Ogni decisione nella catena è un’allocazione di questi mezzi.
In secondo luogo, l’obiettivo non è un vago miglioramento in termini di efficienza o competitività, ma un aumento del profitto a lungo termine, aggiustato per il rischio, dell’azienda. Non uso “a lungo termine” in senso vago. Un miglioramento a breve termine che danneggia la fiducia dei clienti, l’affidabilità dei fornitori o la posizione normativa non è un successo della supply chain, anche se fa sembrare migliori i numeri di questo trimestre. Se prendiamo sul serio la lente economica, dobbiamo considerare esplicitamente il tempo e il rischio.
In terzo luogo, poiché i mezzi sono scarsi e il futuro è incerto, ogni decisione è una scommessa. Quando decidi quanto di un prodotto acquistare, dove posizionarlo e a quale prezzo venderlo, stai effettuando un portafoglio di scommesse sulla futura domanda, sui costi e sui vincoli. La qualità di queste scommesse può essere valutata solo in relazione ad alternative: altre quantità, altre allocazioni, altri prezzi.
In altre parole, una supply chain è un sistema di scommesse sull’uso futuro delle risorse scarse.
Una volta accettato ciò, molte pratiche comuni appaiono diverse. Una previsione della domanda senza un legame esplicito alle decisioni non è un oggetto scientifico, ma una narrazione sul futuro. Un KPI che non può essere tradotto in impatto economico è un indicatore decorativo. Un meeting di pianificazione che genera consenso senza esporre i compromessi in termini finanziari è un rituale politico, non un processo decisionale.
Come la pratica del mainstream devia senza un’ancora economica
Non è che i professionisti della supply chain del mainstream non siano consapevoli dei compromessi. Al contrario, la maggior parte del lavoro quotidiano consiste nel gestirli.
Il problema è che, senza un esplicito ancoraggio economico, i compromessi vengono gestiti localmente, caso per caso, e comunicati tramite indicatori sostitutivi.
Un team ottimizza per i livelli di servizio rispettando un budget. Un altro ottimizza per l’utilizzo del trasporto rispettando i vincoli di tempo di consegna. Un terzo ottimizza per l’efficienza della fabbrica nel rispetto delle normative sul lavoro. Ognuno produce argomentazioni e KPI che sono corretti all’interno del loro compartimento eppure collettivamente incoerenti.
A livello organizzativo, cerchiamo di risolvere questo problema con framework di integrazione: S&OP, IBP, comitati direttivi cross‑funzionali, consigli dei fornitori, programmi di collaborazione con i clienti. Questi migliorano certamente il flusso di informazioni e riducono le contraddizioni evidenti.
Ma se tutte queste conversazioni non sono riunite a una logica economica condivisa—mezzi scarsi, usi alternativi, valutazione esplicita delle scelte—rimaneranno vulnerabili a una deriva silenziosa. Chiunque controlli la narrazione o il dashboard dei KPI per un determinato anno può dichiarare una vittoria locale, indipendentemente da ciò che accade al tasso di rendimento complessivo dell’azienda.
È qui che diventa più evidente il divario con la visione economica in stile Robbins. Dal punto di vista di Robbins, una teoria economica che non può essere falsificata in termini di come gestisce la scarsità non è davvero economia. È ideologia, o nella migliore delle ipotesi una raccolta di euristiche.
Per analogia, un metodo di supply chain che non può essere valutato in termini del suo effetto sul profitto a lungo termine, aggiustato per il rischio, non è davvero economia applicata. È folklore operativo.
Il profitto come disciplina
Adesso affrontiamo un malinteso comune. Quando insisto sul profitto come obiettivo dominante per la supply chain, alcuni lettori lo interpretano come una dichiarazione di valori: “contano solo i rendimenti per gli azionisti,” o “intangibili come il benessere dei dipendenti non sono rilevanti.”
Non è questo ciò che intendo. Considera il profitto come una disciplina.
Il profitto, quando misurato correttamente nel lungo termine, ci costringe ad aggregare tutte le conseguenze delle nostre decisioni, comprese quelle scomode da quantificare. Se maltratti i dipendenti, i costi del lavoro potrebbero sembrare inferiori quest’anno, ma i costi di formazione, il turnover e i tassi di errore aumenteranno. Se trascuri i vincoli ambientali, potresti risparmiare sulla conformità oggi e affrontare multe, divieti o reazioni negative da parte dei clienti domani. Se intimidi i fornitori, i prezzi d’acquisto potrebbero diminuire per un po’, per poi aumentare bruscamente quando essi escono o si vendicano.
In un ambiente competitivo sano, questi effetti non sono astrazioni. Si manifestano, prima o poi, come differenze nei flussi di cassa e nei profili di rischio. Il profitto, in questo senso, è il tabellone che riassume il successo o il fallimento dell’azienda nel navigare la scarsità nel tempo.
Per la supply chain, adottare il profitto come obiettivo organizzativo significa qualcosa di molto concreto: ogni modello, ogni regola, ogni processo che afferma di essere “migliore” dovrebbe essere esprimibile come un’ipotesi sui flussi di cassa futuri e sul rischio, e quindi testabile rispetto alle alternative.
Se proponi una nuova politica di approvvigionamento, la domanda rilevante non è “sembra più intelligente?”, ma “migliora il profitto scontato atteso, dato ciò che sappiamo su domanda, costi e vincoli?” Se introduci un nuovo KPI, la domanda è “come si traduce un miglioramento di questo KPI in guadagni economici, e in quali condizioni potremmo sbagliare?”
Questo tipo di disciplina è raro nelle discussioni della supply chain del mainstream. Non è impossibile. Semplicemente non viene richiesto.
Rileggere le definizioni del mainstream attraverso una lente economica
Ritorniamo alle definizioni del mainstream per un momento e vediamo come appaiono una volta imposta questa disciplina.
Quando il CSCMP dice che il supply chain management integra l’offerta e la domanda tra le aziende e coordina approvvigionamento, produzione e logistica, stanno descrivendo la superficie del sistema: chi parla con chi e di cosa.
Non c’è nulla di sbagliato in questo. Integrazione e coordinamento sono necessari. Ma non sono un fine in sé. Se adottiamo la lente economica, dobbiamo chiederci: integrazione a vantaggio di cosa? Coordinamento al servizio di quali scelte tra gli usi alternativi dei mezzi scarsi?
Allo stesso modo, quando i libri di testo parlano di massimizzare il “supply chain surplus,” l’idea è promettente. Il surplus è definito come il valore percepito dal cliente meno il costo totale sostenuto dalla catena. Se potessimo misurare e ottimizzare quel numero, staremmo davvero facendo qualcosa di molto vicino all’economia applicata.
In pratica, tuttavia, il surplus rimane quasi sempre una figura concettuale. Non osserviamo direttamente la disponibilità a pagare del cliente. Non catturiamo tutti i costi della supply chain a livello delle singole decisioni. Non portiamo sistematicamente l’incertezza fino al risultato.
Quindi, il surplus serve come una narrazione su quello che dovrebbe accadere se i nostri molti indicatori locali si allineassero correttamente. Di solito non serve come criterio decisionale operativo. È esattamente il divario che voglio colmare.
Cosa cambia se trattiamo veramente la supply chain come economia applicata?
Se prendiamo Robbins sul serio e decidiamo che la supply chain è l’economia applicata dei flussi fisici in condizione di incertezza, seguiranno diverse conseguenze pratiche.
La prima è che modelli e sistemi devono essere costruiti attorno alle decisioni, non attorno a previsioni o report. Una previsione che non può essere collegata a una regola decisionale e valutata economicamente è solo una narrazione. Un dashboard che non può essere collegato a un cambiamento nei flussi di cassa è solo decorazione.
La seconda è che ogni scelta significativa—il livello di scorte per prodotto e località, l’itinerario dei flussi, la tempistica della produzione, la struttura dei contratti—dovrebbe, almeno in linea di principio, essere giustificata da un confronto dei risultati economici attesi in condizioni di incertezza. In alcune situazioni, ciò può essere fatto con modelli finanziari piuttosto espliciti. In altre, ci affideremo a delle approssimazioni e a degli esperimenti. Ma la direzione è chiara: allontanarsi dal “perché il KPI aumenta” e muoversi verso “perché la scommessa economica è migliore.”
Il terzo punto è che il confine della supply chain si sposta. Se siamo veramente interessati a destinare mezzi scarsi ai loro migliori usi lungo i flussi fisici, allora le decisioni riguardanti prezzi, assortimento e promozioni non possono essere completamente delegate al “marketing” e trattate come “domanda” esogena. Esse fanno parte di come generiamo e plasmiamo il flusso delle merci, e consumano mezzi scarsi: capacità, capitale e rischio. Gestirli senza una visione economica della supply chain è altrettanto pericoloso quanto gestire la produzione senza conoscere i costi.
Infine, questa prospettiva ci costringe ad ammettere che la supply chain non è un gioco di ottimizzazione neutrale. È una disciplina incentrata sul potere e sulla responsabilità all’interno dell’azienda. Chiunque progetti le regole di allocazione per le risorse scarse—sia attraverso software, politiche o processi—ha un impatto diretto sul destino economico dell’azienda. Fare questo basandosi sulla tradizione, sull’imitazione o su KPI locali non è solo non scientifico; è sconsiderato.
Riflessioni finali
La mia affermazione non è che il pensiero tradizionale sulla supply chain sia inutile. Al contrario, ha accumulato molti preziosi spunti sulla coordinazione, il design dei processi e gli strumenti tecnici. Né sostengo che tutti debbano diventare economisti in senso accademico.
La mia affermazione è al contempo più modesta e più radicale.
È modesta perché non propone alcuna nuova parola d’ordine affascinante. Chiede semplicemente di prendere sul serio la definizione di economia di Robbins e di riconoscere che ciò che stiamo già facendo, ogni giorno, quando decidiamo cosa acquistare, dove stoccare e come muoverlo, è un ragionamento economico sui mezzi scarsi e sui loro usi alternativi.
È radicale perché, una volta accettato ciò, non possiamo più accontentarci di metodi che non possono essere espressi e testati in termini economici. “Non contrario al profitto” non è più una giustificazione sufficiente. “Migliora questo KPI” non è più un argomento sufficiente. “Best practice del settore” non è più una difesa sufficiente.
Se la supply chain è economia applicata, allora il nostro lavoro deve essere giudicato nella stessa valuta che giudica ogni attività economica: la capacità dell’azienda di trasformare i mezzi scarsi in valore duraturo, misurato nel tempo, in condizioni di incertezza, in monete.
Tutto il resto è una narrazione.