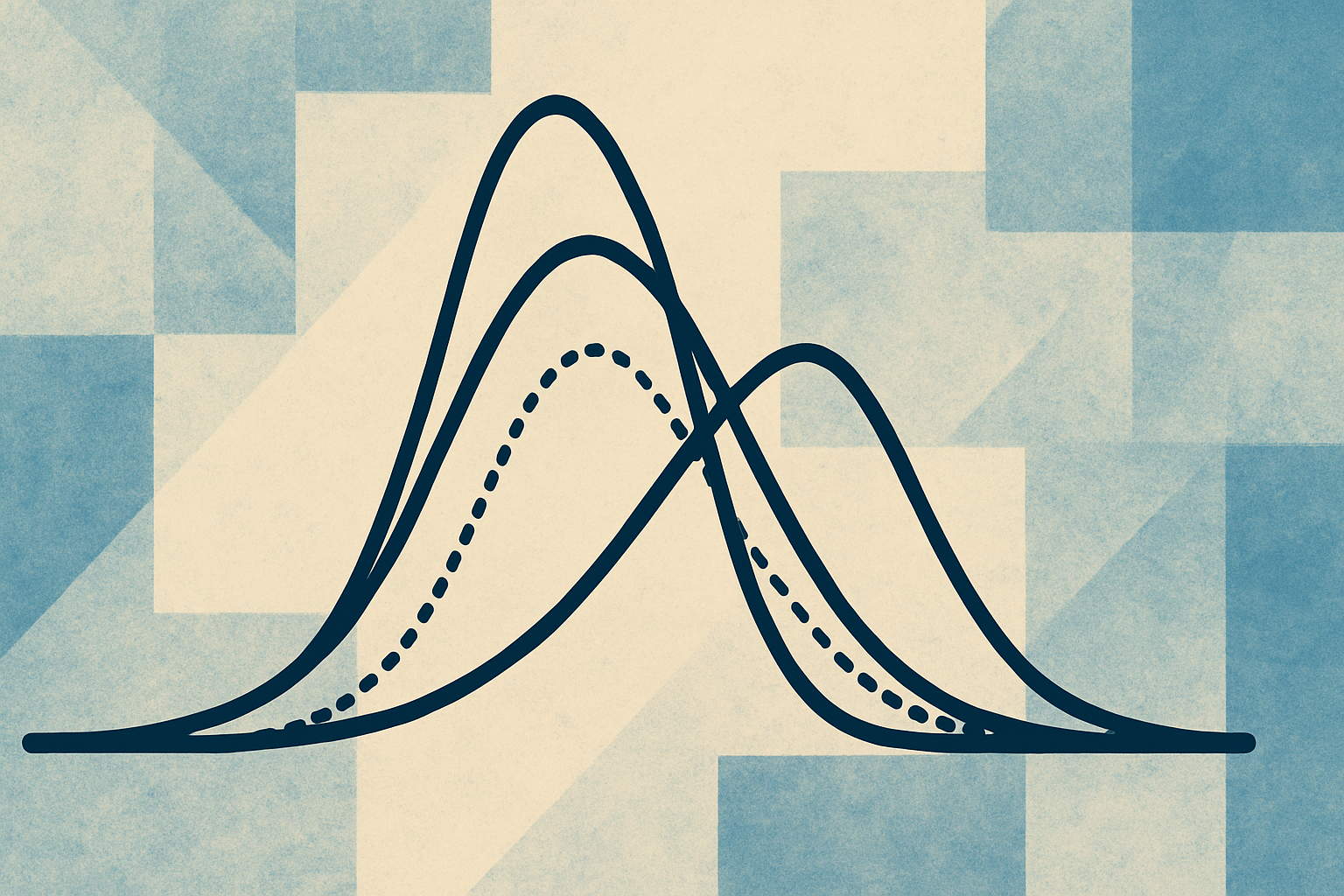Una riflessione sul lavoro di David Simchi-Levi
Tra i professionisti della supply chain, mi viene spesso chiesto come le mie opinioni si relazionino con quelle di David Simchi-Levi, i cui libri di testo e ricerche hanno plasmato gran parte del vocabolario moderno del settore. È una domanda naturale: molti praticanti hanno appreso la supply chain attraverso i suoi modelli e studi di caso molto prima di imbattersi nel mio lavoro. Le nostre conclusioni spesso coincidono, ma i percorsi che percorriamo per raggiungerle differiscono in modi importanti, e queste differenze — su come inquadriamo la disciplina, il futuro e il ruolo del software — hanno conseguenze pratiche su come le aziende progettano e gestiscono le loro supply chain.

Ho esposto le mie opinioni in maniera più approfondita altrove, più recentemente nel mio libro Introduction to Supply Chain e nell’articolo Supply Chain as Economic Bets in a Market-Driven World, ma qui la mia intenzione è modesta: chiarire la mia prospettiva mettendola a confronto con quella di Simchi-Levi. Mi concentrerò sul suo ampiamente letto libro di testo Designing and Managing the Supply Chain e sul suo testo di management Operations Rules, oltre che sul suo lavoro sul rischio della supply chain e sulla digitalizzazione.
Cosa stiamo effettivamente gestendo?
Se si chiede a un tipico testo di operations in cosa consista il management della supply chain, è probabile che si legga una variazione della seguente definizione: l’integrazione di fornitori, fabbriche, magazzini e negozi affinché il prodotto giusto venga consegnato al posto giusto, al momento giusto, al costo totale minimo, in base ai requisiti di servizio. Il libro di testo di Simchi‑Levi rimane fedele a questo spirito e riesce a sviluppare modelli attorno ad esso con efficacia.
Questa definizione non è sbagliata; è semplicemente incompleta. Descrive le strutture di base, ma non il gioco in corso.
Per me, la supply chain è prima di tutto un’attività economica. Le aziende non si occupano di “minimizzare i costi della logistica” o “massimizzare i livelli di servizio” in astratto. Esse si occupano di allocare risorse scarse che hanno usi alternativi – denaro, capacità, spazio sugli scaffali, persino l’attenzione dei pianificatori – nella speranza di ottenere maggiori guadagni, più rapidamente piuttosto che più tardi. In tal senso, la supply chain è economia applicata in condizioni di incertezza, incarnata attraverso il software. Sviluppo questa visione in modo più sistematico – descrivendo la supply chain come un portafoglio di scommesse economiche in condizioni di incertezza – in Supply Chain as Economic Bets in a Market-Driven World.
Una volta che si guarda alla supply chain in questo modo, l’oggetto centrale non è il camion o il magazzino, ma l’opzione: la capacità di fare qualcosa di prezioso quando le circostanze si rivelano in un modo piuttosto che in un altro. L’inventario è un’opzione per vendere. La capacità produttiva in eccesso è un’opzione per reagire a un’impennata. Un secondo fornitore è un’opzione per evitare di essere tenuti in ostaggio. L’obiettivo della disciplina è coltivare ed esercitare tali opzioni in modi che generino ritorni superiori.
Simchi‑Levi riconosce certamente l’incertezza, e ha scritto ampiamente sul pooling del rischio, sulla mitigazione degli effetti a frusta e sulla progettazione di reti flessibili. Dove differiamo è che per lui l’incertezza è qualcosa da controllare; per me essa è la stessa sostanza da cui la supply chain estrae valore.
Funzioni obiettivo: denaro contro proxy
Un secondo ambito in cui le nostre prospettive divergono è la questione di ciò che stiamo cercando di ottimizzare.
Nel libro Designing and Managing the Supply Chain, la formulazione standard è quella di minimizzare il costo totale del sistema – produzione, trasporto, inventario, strutture – in base ai vincoli relativi al livello di servizio e alla capacità. Questo è il linguaggio con cui molti modelli di ottimizzazione nella ricerca operativa sono stati scritti: una somma pesata dei costi qui, un vincolo sul livello di servizio là.
Nei Operations Rules, Simchi‑Levi compie un passo importante in avanti. Egli insiste sul fatto che la strategia operativa debba essere ancorata alla proposta di valore dell’azienda e sostiene che la flessibilità sia l’abilitatore chiave che collega le operazioni al valore per il cliente. Questo è un messaggio potente, e sono pienamente d’accordo sull’idea che la flessibilità abbia un valore sproporzionato.
Ciò che trovo problematico è lasciare la funzione obiettivo al livello di “costi e livelli di servizio” o “valore per il cliente” senza far passare tutto attraverso il ristretto filtro del denaro e del tempo. Se non riduciamo le nostre numerose metriche a qualcosa come un tasso di ritorno sul capitale e sul rischio impiegati, stiamo effettivamente ottimizzando dei proxy. I proxy sono comodi, ma sono anche fonti sottili di disallineamento. È del tutto possibile migliorare i livelli di servizio e ridurre i costi locali pur distruggendo il valore per gli azionisti, una volta che intensità di capitale, rischio e costo opportunità sono adeguatamente considerati.
Questo non è un invito a venerare un unico KPI magico. È un richiamo a riconoscere che, in fin dei conti, le decisioni relative alla supply chain sono decisioni di investimento. Dovrebbero essere inquadrate e giudicate come tali.
Pianificare il futuro contro prepararsi ad esso
Una terza differenza riguarda la nostra posizione nei confronti del futuro stesso.
L’opera di Simchi‑Levi presume, in maniera ragionevole, che le aziende pianificheranno. Le previsioni vengono affinate, i processi push e pull vengono separati, vengono fissati obiettivi di inventario e allocate capacità. Modelli migliori, il pooling del rischio e contratti rendono questi piani più robusti. La visione di base è che esista un “buon” piano per la rete, e che il nostro compito sia quello di avvicinarsi ad esso nonostante l’incertezza.
La mia esperienza nel settore industriale mi ha reso diffidente nei confronti di questo mindset di pianificazione. Non perché la pianificazione sia inutile, ma perché il modo in cui viene praticata tende a confondere previsione e controllo. Le previsioni sono trattate come una sorta di verità fragile sul futuro. Una volta concordate, esse diventano un vincolo a cui tutti devono conformarsi. Le deviazioni vengono viste come fallimenti nell’esecuzione piuttosto che come segnali provenienti dalla realtà.
A mio parere, il futuro non è una specifica ingegneristica che possiamo soddisfare se ci impegniamo abbastanza sui nostri fogli di calcolo di pianificazione. È un ambiente conteso, dipendente dal percorso e profondamente incerto, plasmato da concorrenti, regolatori, clienti ed eventi casuali. In questo contesto, la domanda chiave non è “Qual è il piano giusto?”, ma “Quale portafoglio di opzioni ci serve affinché, quando il futuro ci sorprende, ci aiuti più spesso che danneggi?”
Il lavoro di Simchi‑Levi sull’esposizione al rischio riguarda proprio questo portafoglio, anche se lui utilizza un linguaggio diverso. Il suo Risk Exposure Index, costruito sulle nozioni di tempo di recupero e tempo di sopravvivenza, offre un modo quantitativo per identificare quali strutture o fornitori rappresentino il maggior rischio di interruzione e per dare priorità alle misure di mitigazione. Apprezzo questo approccio. La mia critica non è rivolta allo strumento, bensì alla convinzione residua che, una volta che abbiamo adeguato la nostra rete e condotto i test di stress, siamo “di nuovo sulla buona strada” verso un piano.
Dalla mia parte, sostengo un approccio decisionale meno incentrato sul convergere verso una singola previsione e più sul valutare e rivalutare continuamente le opzioni man mano che arrivano nuove informazioni. In pratica, ciò significa abbracciare visioni probabilistiche della domanda e dell’offerta, integrandole direttamente nella logica delle decisioni stesse, invece di trattarle come una attività separata di previsione che alimenta le riunioni di pianificazione. Ho esposto per la prima volta questa critica alle previsioni a numero unico e alla pianificazione per consenso nella sezione “Forecasts, plans, and the illusion of certainty” di Supply Chain as Economic Bets in a Market-Driven World.
Il ruolo del software: dai record alle decisioni
Qui, il contrasto non è tanto tra Simchi‑Levi e me, quanto tra due epoche.
Simchi‑Levi scrive secondo la tradizione della ricerca operativa. I suoi libri presentano modelli – per il design della rete, per l’inventario, i contratti, la flessibilità – e studi di caso che mostrano come le aziende possano utilizzare questi modelli per migliorare le prestazioni. La tecnologia dell’informazione appare come un facilitatore: un modo per implementare una pianificazione migliore, raccogliere dati migliori e, più recentemente, applicare analytics e machine learning su larga scala. Il suo lavoro più recente combina esplicitamente digitalizzazione, analytics e automazione come i tre pilastri di una moderna supply chain.
Condivido questo entusiasmo per i dati e l’analytics, ma pongo molta più enfasi sull’architettura del software in sé. Negli ultimi due decenni, la maggior parte delle grandi aziende si è ritrovata con una serie di “systems of records” – ERP, WMS, TMS e simili – per registrare le transazioni. Sopra a questi, hanno costruito o acquistato strumenti di reporting e pianificazione che segmentano e analizzano la storia e aiutano a coordinare le decisioni umane. Quello che manca ancora, per lo più, è uno strato dedicato il cui unico scopo sia prendere e eseguire decisioni automaticamente, su larga scala, in condizioni di incertezza.
Questi sistemi decisionali non sono semplicemente “report intelligenti”. Essi codificano una logica economica reale: qual è il trade-off accettabile tra il rischio di esaurimento delle scorte e il costo opportunità del capitale; quando è razionale pagare per una seconda fonte; come riallocare la capacità scarsa quando la domanda esplode in una regione e crolla in un’altra. Funzionano quotidianamente, o ogni ora, con un intervento umano minimo. La loro performance viene misurata non dai risparmi previsti in un business case, ma dai flussi di cassa realizzati.
Niente negli scritti di Simchi‑Levi contraddice questa visione. Al contrario, la sua insistenza sul fatto che le aziende dovrebbero utilizzare analytics e machine learning per ottenere prezzi, promozioni e operazioni migliori è pienamente in linea con essa. Dove insisto maggiormente è nel sostenere che, a meno che le aziende non trattino l’ingegneria di questi sistemi decisionali come un problema software di prim’ordine, non beneficeranno mai pienamente dei modelli e delle intuizioni che accademici come lui hanno prodotto per decenni.
Incentivi e il sistema umano attorno ai modelli
I modelli e il software non vivono in un vuoto. Essi si trovano all’interno di organizzazioni popolate da persone con incentivi, paure e piani di carriera. Anche qui, il mio focus è leggermente diverso da quello di Simchi‑Levi.
I suoi libri di testo riconoscono obiettivi disallineati tra approvvigionamento, produzione, logistica e vendite, e discute meccanismi contrattuali e schemi di coordinamento per allineare i partner della supply chain. Questo è un argomento importante, e il suo lavoro su contratti, flessibilità e condivisione del rischio è ampiamente citato.
La mia esperienza con grandi implementazioni mi ha reso più pessimista su quanto facilmente questi disallineamenti possano essere risolti soltanto con buona volontà e contratti ingegnosi. Alcuni conflitti di interesse sono strutturali. Un fornitore di software pagato a seduta ha pochi incentivi ad automatizzare il lavoro dei pianificatori. Un consulente che fattura a giornata difficilmente raccomanderà la soluzione più semplice che renderebbe la sua presenza superflua. Una funzione il cui prestigio dipende dal numero di dipendenti resisterà istintivamente all’automazione.
Questi non sono fallimenti morali; sono semplicemente comportamenti prevedibili in certe strutture di incentivo. Per i leader della supply chain, l’implicazione è che l’architettura del sistema decisionale include anche quella del sistema umano attorno ad esso: chi possiede quali decisioni, chi viene ricompensato per cosa, chi ha l’autorità di passare da modalità manuali ad automatizzate. Senza questo, anche i migliori framework analitici saranno domati in qualcosa di politicamente accettabile ma economicamente mediocre.
Convergenze da preservare
Finora ho enfatizzato le differenze, perché sono esse che chiariscono la mia posizione. È altrettanto importante riconoscere dove Simchi‑Levi e io convergiamo, perché queste convergenze ci dicono qualcosa sulla direzione in cui il settore si sta muovendo, indipendentemente dal punto di partenza filosofico.
Entrambi trattiamo le supply chain come sistemi e rifiutiamo l’ottimizzazione locale e compartimentalizzata. Entrambi consideriamo l’incertezza e la variabilità come elementi centrali, e non come fastidi periferici. Entrambi riteniamo che la flessibilità – che si chiami flessibilità o optionality – sia di valore sproporzionato, e che le aziende debbano essere disposte a pagarla. Entrambi vediamo i dati, l’analytics e l’automazione come essenziali per qualsiasi tentativo serio di miglioramento.
Queste convinzioni condivise non sono banali. Vent’anni fa, il discorso dominante in molte sale riunioni era incentrato su lean, just‑in‑time e single‑sourcing – l’efficienza come fine a se stessa. Oggi, dopo lockdown, guerre e crisi finanziarie, la conversazione si sta lentamente spostando verso la resilienza, l’optionality e le capacità digitali. Il lavoro di Simchi‑Levi sull’esposizione al rischio ha contribuito a spingere questo cambiamento nelle sale riunioni e persino negli ambienti della politica pubblica. Vedo il mio lavoro come parte dello stesso movimento, sebbene con un’enfasi e un vocabolario diverso.
Perché i dettagli filosofici contano
Ci si potrebbe chiedere: se le prescrizioni spesso fanno rima – più flessibilità, migliori analytics, un design più olistico – perché darsi la pena di discutere questioni filosofiche sugli obiettivi e sulla natura del futuro?
Perché, in pratica, questi dettagli filosofici trapelano nelle decisioni progettuali.
Se pensi in termini di “minimizzare i costi per un dato livello di servizio”, sarai tentato di trattare gli obiettivi di servizio come esogeni e di solidificarli in vincoli. Se invece pensi in termini di “massimizzare il ritorno economico in condizioni di incertezza”, è più probabile che metterai in discussione se gli obiettivi di servizio siano economicamente giustificati, e li adatterai dinamicamente man mano che le condizioni cambiano.
Se vedi il futuro come qualcosa che può essere approssimato da un unico piano, investirai pesantemente in cicli di pianificazione, riunioni e nella creazione del consenso. Se lo consideri invece come una fonte di sorprese da sfruttare, investirai di più in pipeline di dati, motori decisionali automatizzati e opzioni che ti diano margine di manovra quando i piani inevitabilmente si rompano.
Se consideri l’IT principalmente come una funzione di supporto per implementare una migliore pianificazione, acquisterai un altro modulo per il tuo ERP. Se lo vedi come il mezzo nel quale risiede la tua logica economica, ti preoccuperai della separazione tra systems of record e systems of decision, della versioning dei modelli, della sperimentazione e del rollback sicuro.
Il lavoro di Simchi‑Levi spinge le aziende nelle giuste direzioni su molti di questi fronti. Il mio contributo consiste nell’affermare che dobbiamo andare oltre: trattare supply chain come una disciplina decision‑engineering economica il cui ambiente naturale è il software; misurare il nostro successo, in definitiva, in denaro e tempo; e costruire organizzazioni e sistemi che considerino l’incertezza non come un nemico da sopprimere ma come la materia prima del profitto.
Su questi punti, il contrasto non è personale. È una scelta che ogni supply chain leader deve fare.