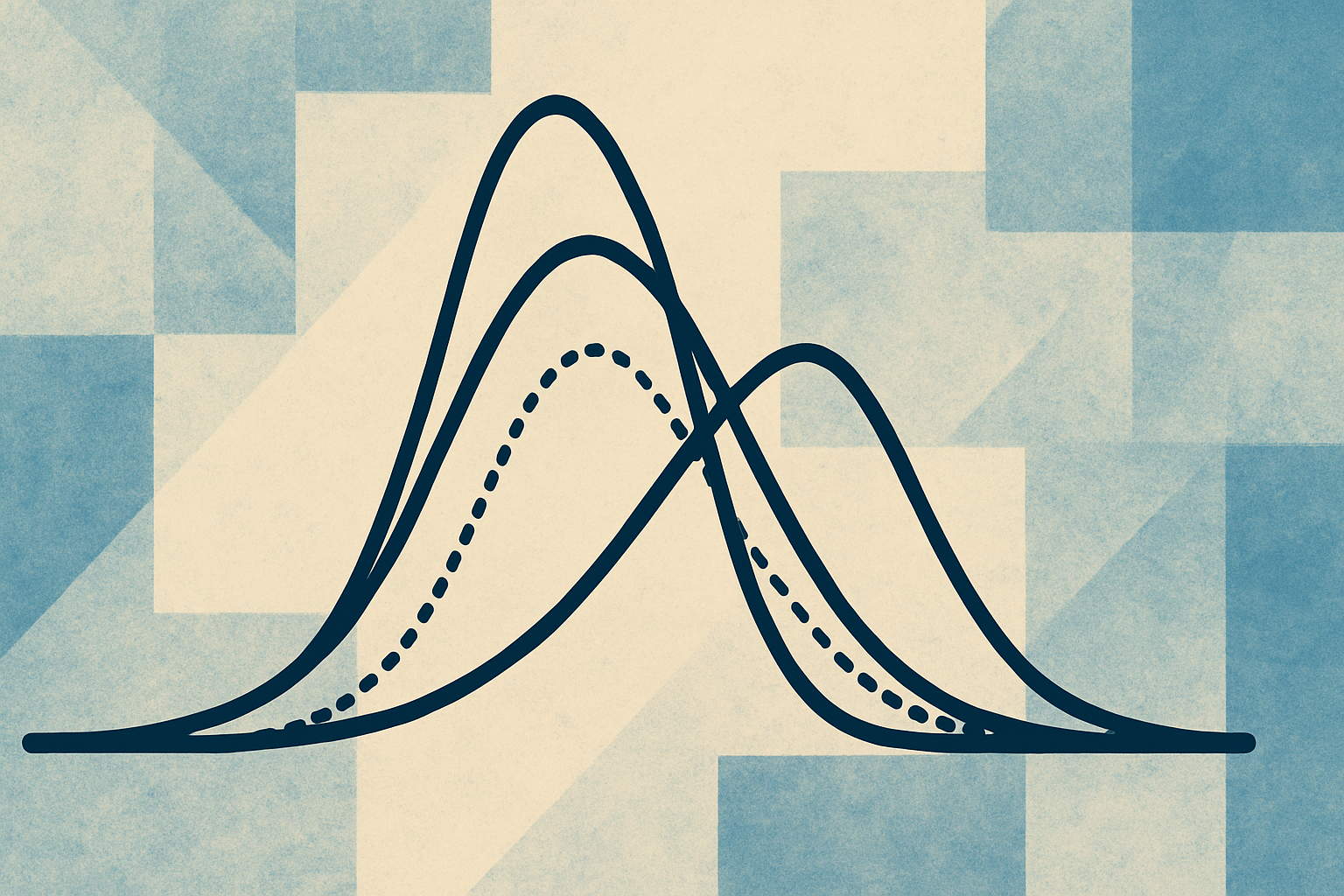Resilienza della Supply Chain Riconsiderata
Negli ultimi anni, “resilience” è diventata una di quelle parole che i dirigenti si sentono obbligati a usare in ogni seconda frase. Dopo ogni interruzione – un lockdown, una guerra, un canale bloccato – torna sempre la stessa domanda: “Come rendiamo la supply chain più resiliente?” Le conversazioni sono sincere; le risposte spesso risultano vaghe. “Maggiore visibilità,” “maggiore collaborazione,” “maggiore agilità” – parole che suonano positive, ma che spiegano ben poco su cosa dovremmo effettivamente fare di diverso, ogni giorno, quando decidiamo cosa acquistare, produrre, spostare e fissare il prezzo.

Nel mio libro Introduction to Supply Chain, ho proposto una visione della supply chain come la gestione disciplinata delle decisioni sotto incertezza, con l’economia – non i livelli di servizio o l’utilizzo – come metro principale. Quella visione ha plasmato il mio modo di pensare alla resilienza. Infatti, mi ha portato a una definizione molto più ristretta di quella che si trova tipicamente nei manuali, nelle brochure di consulenza o nei programmi di certificazione.
Cosa intendo per resilienza
Quando parlo di resilienza della supply chain, ho in mente qualcosa di molto specifico.
Un’azienda – e la sua supply chain – è resiliente se riesce a resistere a uno shock sistemico e imprevisto che minaccia il flusso delle merci, per poi ripristinare quel flusso allo stato precedente.
Ci sono due qualificatori importanti in questa frase.
Il primo è “imprevisto.” Molti eventi spiacevoli non sono shock in questo senso. Un’impennata stagionale, una promozione che funziona meglio del previsto, il fatto che i tempi di consegna siano variabili anziché costanti – nulla di tutto ciò è nuovo o misterioso. Può essere difficile da modellare con precisione, ma non rientra nell’ambito di un’anticipazione ragionevole. Se esaurisci le scorte ogni Natale, non si tratta di un problema di resilienza; è un problema di pianificazione.
Il secondo qualificatore è “sistemico.” Un singolo negozio che perde elettricità, un camion che si guasta, un fornitore che salta una spedizione: si tratta di incidenti locali. Possono essere irritanti o addirittura costosi, ma non minacciano la continuità del flusso nel suo insieme. Un grande porto che chiude per mesi, uno shock normativo che improvvisamente rende una categoria invendibile, una guerra che blocca le rotte commerciali in un’intera regione – qui entriamo nel territorio sistemico.
La resilienza, nel mio vocabolario, è riservata a quegli eventi rari e ad alto impatto che sia (a) non potevano essere pianificati nei dettagli in modo ragionevole, sia (b) che colpiscono una parte sostanziale della supply chain simultaneamente.
Tutto il resto – il rumore quotidiano della domanda, la disattenzione nei tempi di consegna, la normale danza delle promozioni, le prevedibili azzardate dei concorrenti – dovrebbe essere affrontato attraverso una buona pratica della supply chain, e non inquadrato come “resilience.”
Come il mainstream parla di resilienza
Se osservi come i grandi fornitori tecnologici, le associazioni professionali e le organizzazioni politiche descrivono la resilienza, vedrai un quadro diverso.
Una definizione abbastanza tipica presenta la resilienza della supply chain come la capacità di anticipare, adattarsi e riprendersi dalle interruzioni, mantenendo operative le attività. L’accento è sulla continuità: il sistema dovrebbe continuare a fornire livelli di servizio accettabili anche quando accade qualcosa di inaspettato.
Le principali associazioni professionali aggiungono un’altra sfumatura: la resilienza è la capacità di tornare a una posizione di equilibrio dopo che le prestazioni si sono discostate dalle aspettative. In questa definizione, la resilienza riguarda il ritorno al “normale” dopo un disturbo, e può essere migliorata avendo maggiori opzioni di risposta e agendo rapidamente su di esse.
Da qui, appare ripetutamente una lista familiare di leve. Ridondanza sotto forma di inventario extra, capacità di backup e fornitori alternativi. Flessibilità tramite una manodopera multi-qualificata e una produzione adattabile. Visibilità e collaborazione, spesso abilitate da piattaforme digitali, per individuare i problemi in anticipo e coordinare le risposte. Recenti rapporti di policy e consulenza aggiungono un ulteriore livello: la necessità di “bilanciare” l’efficienza e la resilienza, talvolta riconfigurando le reti, adeguando le footprint di approvvigionamento o investendo in nuove tecnologie. Le revisioni accademiche, in particolare dalla prospettiva della gestione dell’inventario, catalogano strategie come l’accaparramento, il multi-sourcing, la prenotazione della capacità e i contratti flessibili con l’intestazione di “strategie di resilienza.”
Non c’è nulla di assurdo in questa visione mainstream. Le leve che elenca sono reali; e anche i compromessi che evidenzia sono reali. La mia preoccupazione è che, nel complesso, questo vocabolario trasformi la resilienza in un’etichetta amichevole che si può applicare a quasi ogni progetto di miglioramento: più inventario? È resilienza. Meno inventario, ma in posti “migliori”? Sempre resilienza. Un nuovo dashboard? Resilienza. Un nuovo processo? Di nuovo resilienza.
Quando una parola inizia a significare “qualsiasi cosa che sembri una buona idea”, smette rapidamente di essere utile.
Perché insisto su un confine più netto
Traccio una linea netta tra il dominio della resilienza e quello dell’eccellenza ordinaria della supply chain, perché i due sono governati da diversi tipi di conoscenza.
La maggior parte di ciò che un team di supply chain affronta è incerto, ma non misterioso. La domanda varia, ma in modi che possono essere catturati – in modo imperfetto, ma utile – dai modelli statistici. I tempi di consegna sono variabili, ma la loro variabilità può essere misurata. Promozioni, cambiamenti di prezzo, variazioni nell’assortimento, eventi sul calendario: tutti aggiungono struttura a questa incertezza. Possiamo associare probabilità e conseguenze economiche a molti di questi schemi.
In questo contesto, la domanda giusta non è “Come diventiamo resilienti?” ma: “Data la distribuzione della domanda, dei tempi di consegna e dei prezzi, qual è la miglior decisione economica da prendere oggi?” Una buona decisione, in questo senso, è una scommessa: essa pesa gli esiti possibili e il loro impatto finanziario. Accetta che alcuni giorni perdiamo la scommessa, ma rende quelle perdite ridotte e sostenibili.
Se etichettiamo ogni fallimento nel fare questo correttamente come un “problema di resilienza”, scusiamo molta fragilità evitabile. Una regola di scorta che ignora l’incertezza nei tempi di consegna non diventa rispettabile semplicemente perché diciamo che fa parte di una strategia di resilienza. Un processo di rinnovo che non riesce a gestire le promozioni non soffre di un fallimento della resilienza; è semplicemente mal progettato.
La resilienza, per come uso il termine, inizia solo dove un pensiero probabilistico guidato dall’economia non è più sufficiente – dove ci troviamo di fronte ad eventi che esulano dal repertorio di schemi che i nostri modelli, l’esperienza e i dati possono ragionevolmente coprire.
Le decisioni come scommesse, e perché ciò è importante per gli shock
Anche quando non abbiamo a che fare con shock, ogni decisione nella supply chain è una scommessa sul futuro. Raramente la viviamo così, perché le decisioni sono numerose e ripetitive: un riordino qui, una produzione in lotto là, un camion da instradare, un prezzo da regolare. Ma dietro a ciascuna di queste azioni si cela una visione implicita di ciò che potrebbe accadere e di quanto costoso potrebbe essere ciascun esito.
Ciò che mi interessa è la forma di quella scommessa.
Molte organizzazioni, spesso in maniera inconscia, progettano i loro processi in modo che le decisioni siano estremamente sensibili a una visione limitata del futuro. Una previsione viene trattata come un numero singolo. I livelli di servizio sono considerati soglie sacre. La capacità viene gestita vicina alla saturazione. Quantità minime d’ordine e vincoli rigidi fissano grandi impegni fin dall’inizio. Finché il mondo si comporta all’incirca come previsto, questo sembra efficiente: gli stock sono bassi, l’utilizzo è elevato, i costi sono contenuti.
Nel momento in cui la realtà si discosta – e lo fa sempre, anche senza un lockdown o una guerra – queste decisioni si rivelano fragili. Un modesto inaspettato aumento della domanda, un lieve ritardo di un fornitore o una piccola modifica normativa si propagano attraverso la rete in modi che nessuno aveva previsto, perché le scommesse sottostanti non avevano margine per deviazioni.
Dal mio punto di vista, la resilienza non riguarda principalmente ciò che fai dopo uno shock. Riguarda la struttura delle scommesse che poni prima che accada. Una supply chain che fa costantemente scommesse fragili non diventerà magicamente resiliente quando si verifichi qualcosa di serio. Al contrario, una supply chain che abitualmente valuta correttamente l’incertezza – che accetta un certo margine dove questo costa poco e ammette carenze dannose solo quando sono sostenibili – spesso si comporterà in modo elegante anche sotto pressione.
Questo è il motivo per cui vedo la resilienza come un effetto collaterale di un processo decisionale disciplinato nell’incertezza, e non come un livello separato di processi e dashboard.
Capacità, automazione e il fattore umano
Esiste un altro aspetto, più umano, che viene spesso trascurato: la capacità delle persone che dovrebbero occuparsi della resilienza.
In molte aziende, i team di supply chain vivono in uno stato di continuo gestione delle crisi. Conciliano dati incoerenti provenienti da sistemi multipli, annullano manualmente piani che non hanno senso, passano da un’eccezione all’altra e partecipano a riunioni infinite per spiegare i problemi di ieri. Gli strumenti che avrebbero dovuto semplificare la loro vita invece generano la maggior parte del rumore attraverso il quale devono fare chiarezza.
In un ambiente del genere, chi ha il tempo – o l’energia mentale – per pensare seriamente a shock a bassa frequenza e ad alto impatto? L’agenda è completamente assorbita da problemi urgenti e autoindotti.
La mia posizione è che qualsiasi agenda credibile sulla resilienza inizi liberando questa capacità. Ciò significa automatizzare la stragrande maggioranza delle decisioni di routine, non con regole semplicistiche, ma con motori quantitativi che comprendono l’incertezza e l’economia in modo sufficientemente accurato da fare migliaia di piccole scommesse per conto dell’organizzazione. Quando le macchine si occupano di ciò in cui sono bravi – scelte ripetitive, basate sui dati e sotto regole stabili – gli esseri umani possono concentrarsi su ciò per cui sono unici: immaginare modalità di fallimento che non si sono ancora verificate, mettere in discussione le ipotesi e decidere quali rischi strutturali l’azienda è disposta a sopportare.
Senze questo cambiamento, gran parte del discorso sulla resilienza è solo questo: parole.
Dove mi discosto dalla pratica mainstream
Tutto ciò crea una divergenza silenziosa ma significativa tra la mia visione della resilienza e quella che domina la maggior parte delle conversazioni del settore.
La prima divergenza riguarda le previsioni e il rischio. Nella pratica mainstream, le previsioni sono solitamente trattate come un’attività separata, quasi sacra: un numero singolo per SKU e per periodo, occasionalmente arricchito da scenari. Successivamente interviene la gestione del rischio, con mappe di calore, registri e workshop. Per mia esperienza, questa separazione è artificiale. L’incertezza non è un’aggiunta; è la materia prima di ogni decisione. Quando la riduciamo a previsioni puntuali e poi dipingiamo il “rischio” ai margini, ci stiamo già predisponendo a risultati fragili.
La seconda divergenza riguarda le metriche. Gran parte della letteratura sulla resilienza è inquadrata in termini di tempo di recupero, livelli minimi di servizio accettabili durante una interruzione, indici di esposizione e altri indicatori chiave di prestazione. Questi possono essere utili per la comunicazione, ma se li ottimizziamo direttamente, siamo tentati di trattare la resilienza come una virtù che deve essere aumentata in astratto. Io preferisco una domanda più prosaica: per una determinata categoria di shock, quanto denaro ci aspetteremmo di perdere con l’attuale configurazione, e quanto costerebbe ridurre questa perdita di una certa quantità? Una volta formulata in questo modo, la resilienza smette di essere mistica. Diventa un problema di allocazione del capitale.
La terza divergenza riguarda la ridondanza. Molti playbook sulla resilienza incoraggiano un inventario aggiuntivo, più fornitori, più capacità e più percorsi come cose intrinsecamente positive. Io non condivido tale entusiasmo. Alcuna ridondanza è estremamente preziosa; altra è pura spreco. La differenza risiede nel valore dell’opzione: cosa ci consente di fare questo fornitore aggiuntivo, questa capacità in riserva o questo buffer stock di fronte all’incertezza che non potremmo fare altrimenti, e con quale frequenza è effettivamente probabile che venga utilizzato? Solo rispondendo a questa domanda in termini finanziari possiamo sapere se un determinato “investimento in resilienza” abbia senso.
Infine, c’è la questione della governance. Molto del pensiero mainstream colloca la resilienza in comitati, framework e programmi di certificazione. Questi possono avere il loro posto, ma le decisioni chiave che determinano la resilienza sono spesso di natura imprenditoriale: se concentrare la produzione in un’unica sede molto efficiente o accettare il sovraccarico di più impianti in diverse giurisdizioni; se affidarsi a un piccolo numero di fornitori altamente ottimizzati o mantenere relazioni con alternative che potrebbero essere meno competitive nel breve termine. Queste non sono scelte tecniche all’interno della funzione supply chain; sono decisioni strategiche riguardo ai tipi di shock con cui l’azienda è disposta a convivere.
Resilienza, robustezza e antifragilità
Vale anche la pena distinguere la resilienza da due idee affini: la robustezza e l’antifragilità.
Un sistema robusto è quello che viene appena influenzato da disturbi entro un certo intervallo. Continua a funzionare più o meno come prima. Un sistema resiliente subisce quando uno shock colpisce, ma si riprende. Un sistema fragile è quello che non riesce a riprendersi: lo shock lo spinge oltre il punto di non ritorno.
L’antifragilità, un termine reso popolare da Nassim Nicholas Taleb, va un passo oltre: descrive sistemi che in realtà traggono beneficio dalla volatilità. Guadagnano dal disordine anziché limitarvisi a sopravvivere.
Nei mercati competitivi, un comportamento antifragile tende a prevalere nel lungo periodo. Le aziende che trattano gli shock solo come minacce saranno superate da quelle che li vedono anche come opportunità: per acquisire asset in difficoltà, per spostare quote di mercato, per rinegoziare i termini, per accelerare cambiamenti che altrimenti richiederebbero anni. La supply chain, da sola, non può rendere un’azienda antifragile, ma può sia facilitare che ostacolare questo approccio. Una rete costantemente sull’orlo del collasso non può essere opportunistica quando si verifica una interruzione.
Questo è un altro motivo per cui resisto al trattare la resilienza come un dominio tecnico ristretto. A un certo punto, la conversazione deve toccare l’appetito al rischio fondamentale e l’immaginazione dell’azienda.
Conseguenze pratiche di questa visione
Che cosa significa tutto ciò nella pratica?
Significa che, prima di lanciare i grandi “resilience programs”, dovremmo prima sistemare le basi di come prendiamo decisioni in condizioni di incertezza. Stiamo ancora affidandoci a previsioni basate su un singolo numero e a formule statiche per le scorte di sicurezza che ignorano la variabilità dei tempi di consegna? Stiamo imponendo vincoli rigidi – come quantità minime d’ordine arbitrarie o regole per camion pieni – che eliminano le opzioni in nome della semplicità? Stiamo misurando le prestazioni in modi che premiano illusioni di efficienza a breve termine e nascondono fragilità a lungo termine?
Significa che dovremmo investire seriamente nell’automazione decisionale che si addice al nome: sistemi che integrano visioni probabilistiche della domanda, dei tempi di consegna e dei prezzi, e che ottimizzano per risultati economici anziché per obiettivi arbitrari di tasso di riempimento. Non si tratta di acquistare un dashboard. Si tratta di costruire o adottare motori capaci di assumere la responsabilità di una vasta parte del carico di lavoro combinatorio quotidiano, in modo che gli esperti umani possano concentrarsi su questioni strutturali.
Significa che dovremmo individuare le poche esposizioni veramente sistemiche che contano per il nostro business. Per ciascuna di esse, possiamo porre domande semplici e scomode: se questo porto, questa valuta, questo ambiente regolatorio o questa regione politica non fossero disponibili per un anno, cosa accadrebbe realmente? Sopravvivremmo, e in che modo? Se la risposta onesta è “non lo sappiamo”, allora la misurazione diventa la priorità. Se la risposta è “saremmo finiti”, allora dobbiamo decidere se quel rischio sia accettabile. In caso contrario, il rimedio raramente sarà un gadget; sarà un cambiamento strutturale.
Significa anche accettare che la resilienza ha un prezzo. Una supply chain che è genuinamente più resiliente apparirà spesso meno “efficiente” secondo i parametri ristretti che ci sono stati insegnati a venerare: potrebbe avere più margine di manovra, condividere maggiori profitti con i partner, o mantenere capacità che la maggior parte del tempo sembrano inattive. La questione non è se questo prezzo esista, ma se valga la pena pagarlo in considerazione degli shock che davvero ci interessano.
La resilienza, come la vedo io, non è un nuovo strato di complessità da aggiungere a una disciplina già sovraccarica. È la conseguenza a lungo termine di prendere sul serio l’incertezza e l’economia nelle piccole decisioni quotidiane e di avere il coraggio di compiere alcune grandi scelte strutturali, ben consapevoli degli shock che non possiamo escludere.
Se riserviamo la parola “resilience” per quegli shock, e se trattiamo tutto il resto come lavoro ordinario di supply chain che può e deve essere automatizzato e migliorato senza drammi, allora il termine riacquista la sua acutezza. Diventa qualcosa su cui possiamo ragionare, investire e – quando necessario – deliberatamente bilanciare rispetto ad altri obiettivi.
Questo, almeno, è il tipo di resilienza che mi interessa.