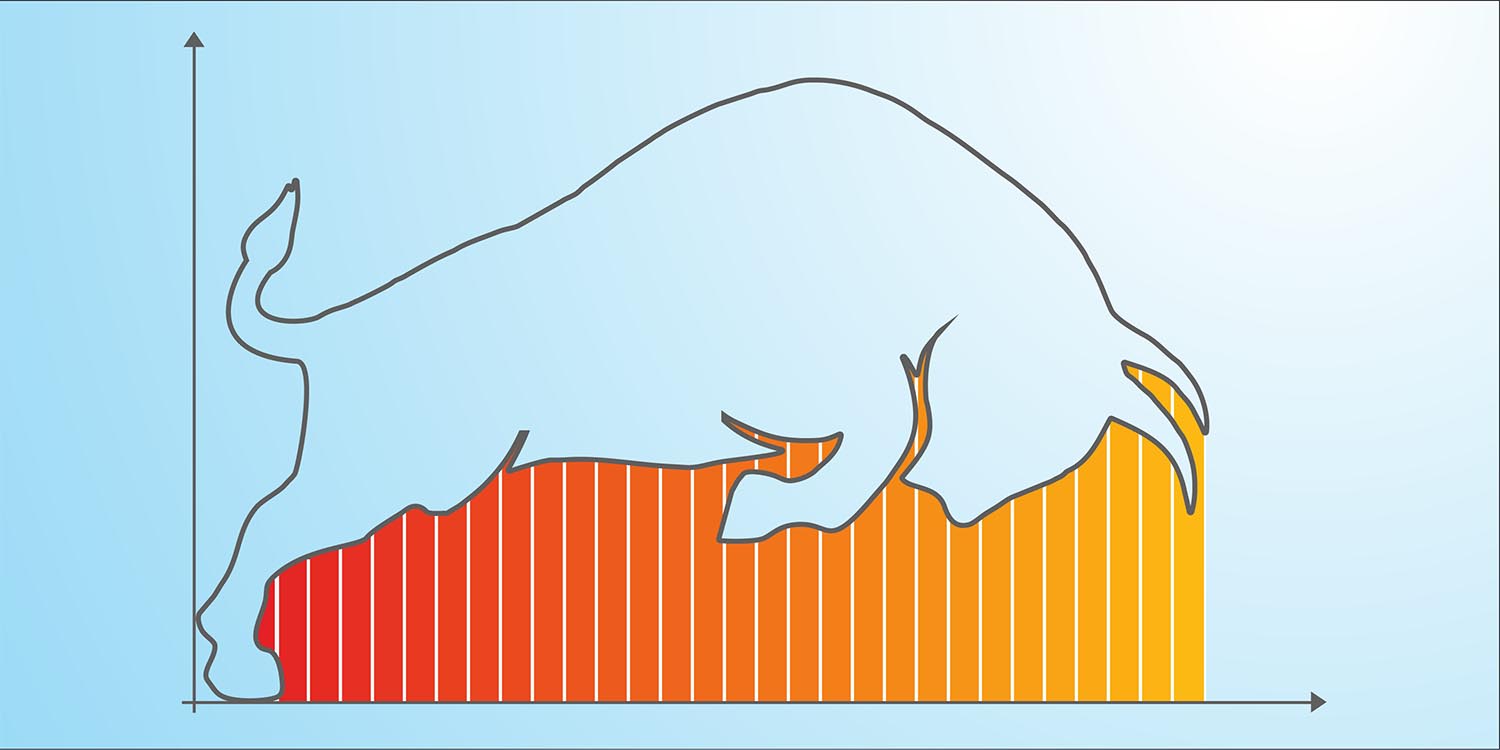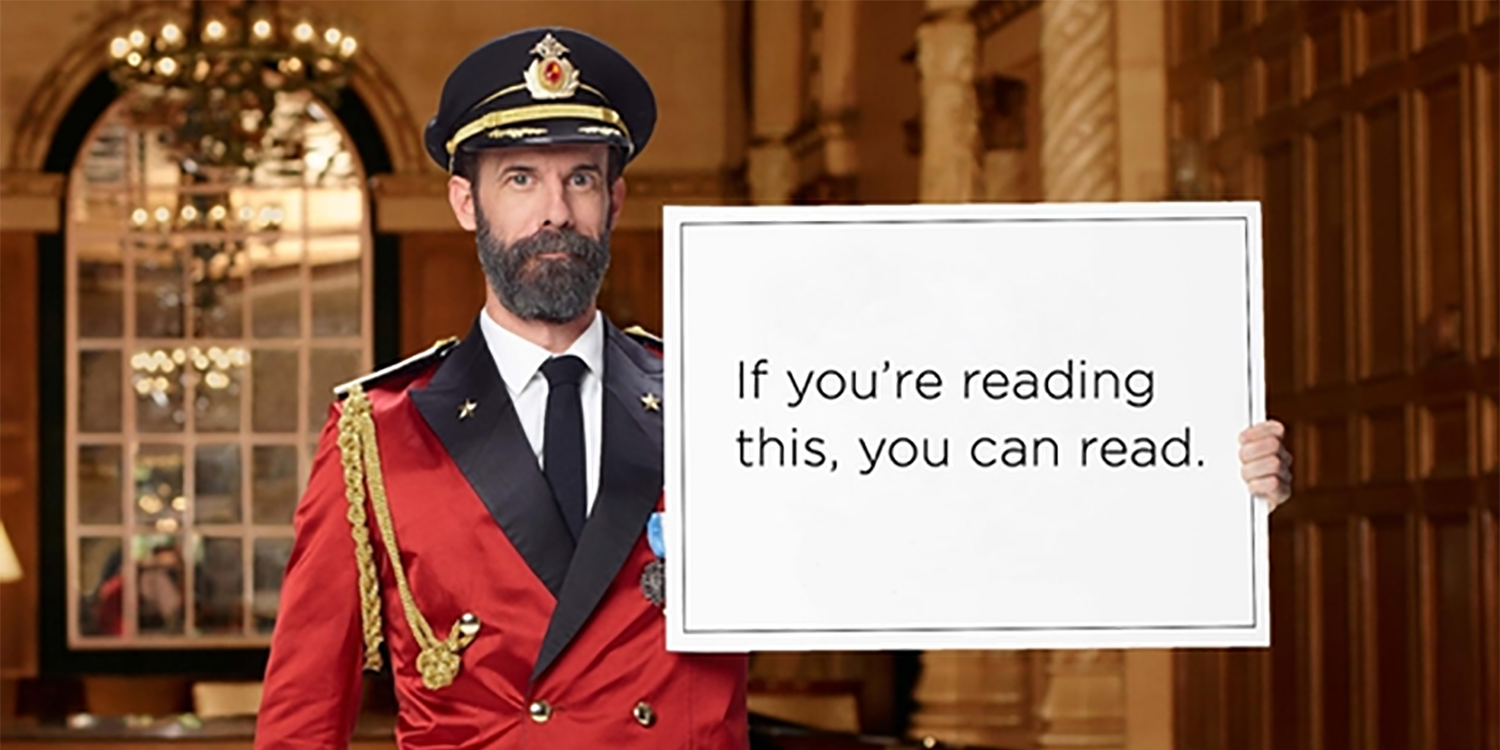Spunti di terminologia supply chain
L’emergere di una terminologia è, nel migliore dei casi, un processo casuale. La supply chain non fa eccezione e, col senno di poi, una notevole porzione della terminologia supply chain risulta inadeguata. Una terminologia confusa penalizza sia i nuovi arrivati che i professionisti esperti. I nuovi arrivati si trovano a lottare con una complessità accidentale più del necessario. I professionisti potrebbero non rendersi conto che il presupposto del loro campo è più precario di quanto appaia.

Esaminiamo i maggiori colpevoli, in termini di terminologia, nella supply chain e proponiamo alternative adeguate. Anche se tali alternative probabilmente non saranno mai adottate dalla comunità, esse dovrebbero far luce su sfumature trascurate. In linea di massima, una buona terminologia dovrebbe essere il più neutra e fattuale possibile. L’inclusione di qualificatori positivi o “cool” è un segnale d’allarme.
ABC analysis avrebbe dovuto essere chiamato moving average segmentation. In termini di terminologia, il termine “ABC” non aggiunge nulla, mentre “analysis” è quanto meno specifico. L’espressione “moving average segmentation” è più delineata, chiarendo i difetti intrinseci associati a questo metodo. Infatti, le moving averages non solo creano instabilità nel tempo, ma non riescono nemmeno a riflettere schemi chiave, come le ciclicità. Inoltre, la segmentation è un meccanismo crude che, per sua natura, non può fornire una risposta granulare a livello di SKU.
APS (Advanced planning and scheduling) avrebbe dovuto essere chiamato planning management. Innanzitutto, non c’è nulla di “advanced” in questi prodotti software. Questo termine fu coniato negli anni ‘90 dagli analisti di mercato per dare slancio a una serie di software vendors. La maggior parte dei prodotti che rientrano nell’ombrello APS non può più essere considerata “advanced” secondo gli standard degli anni 2020. In secondo luogo, il planning management enfatizza processi caratterizzati da immissioni manuali di dati estese. Le capacità statistiche rappresentano solo una minima parte del software. La maggior parte delle funzionalità è dedicata all’utente finale, ossia al supply and Supply Chain Scientist, che gestisce manualmente il piano.
BI (Business Intelligence) avrebbe dovuto essere chiamato cube reporting. Innanzitutto, questo pezzo di tecnologia non ha nulla a che fare né con l’intelligenza intesa come “artificial intelligence”, né con quella intesa come “secret intelligence service”. Pertanto, il termine “intelligence” non appartiene a questo contesto. In secondo luogo, non c’è nulla di intrinsecamente “business” in questa tecnologia. Ad esempio, mostrare le temperature giornaliere passate per codice postale è un ottimo caso d’uso per un cube report. Il cube reporting è un’interfaccia utente sovrapposta a un data store a cubo, noto anche come OLAP (online analytical processing) nel gergo dei database. Il cubo offre operazioni di slice and dice. Sebbene venga utilizzato il termine “cube”, il numero di dimensioni non deve necessariamente essere uguale a 3. Tuttavia, in pratica rimane un numero a cifra singola a causa dell’esplosione combinatoria associata a dimensioni maggiori.
ERP (Enterprise Resource Planning) avrebbe dovuto essere chiamato ERM, acronimo di Enterprise Resource Management. Il loro obiettivo principale è, come suggerisce il nome ERM, quello di tracciare gli asset dell’impresa. Questi prodotti hanno poco o nulla a che fare con il planning. Il design di base dell’ERM, che si fonda pesantemente su un database relazionale, è in contrasto con qualsiasi capacità predittiva. La terminologia “ERP” fu promossa negli anni ‘90 dagli analisti di mercato per incentivare una serie di software vendors che cercavano di differenziarsi dai loro concorrenti. Tuttavia, non c’è mai stata molta sostanza dietro l’aspetto “planning” delle affermazioni. Dal punto di vista software, il mondo transazionale è più distinto che non lo sia mai stato da quello predittivo.
MRP (Material Requirements Planning) avrebbe dovuto essere chiamato MRM (Manufacturing Requirement Management). Le ragioni sono sostanzialmente simili a quelle discusse nel confronto ERP vs. ERM. Coinvolge poca o nessuna pianificazione e, quando c’è, il design tende fortemente verso un processo manuale. Inoltre, il termine requirements è datato, in quanto si riferisce principalmente alla gestione della BOM (distinta base), che al giorno d’oggi rappresenta solo una piccola parte di ciò che comporta la moderna gestione della produzione. Pertanto, vi è poca ragione di enfatizzare in particolare questo termine.
Eaches (EA), un’unità di misura, dovrebbe essere chiamato meglio obvious units (OU). Gli eaches vengono usati quando l’unità di misura rilevante, per il controllo dell’inventario, si presume sia evidente, come di consueto per i prodotti confezionati. Sfortunatamente, l’intento originale si perde nel termine “eaches”. Inoltre, “eaches” risulta grammaticalmente strano. La forma singolare è confusa, ad esempio “1 each”, e pertanto viene evitata in pratica.
EDI (Electronic Data Interchange) ha origine negli anni ‘70 e si riferisce prevalentemente a software che trasmettono ordini di acquisto ai fornitori, eliminando le interruzioni amministrative dal processo di ordinazione. Sfortunatamente, con l’avvento di internet, anche la semplice navigazione web rientra tecnicamente in un processo EDI. Il concetto di integrated suppliers (al contrario di integrated clients), che allude a un’integrazione dei rispettivi sistemi IT, rappresenterebbe un modo migliore di inquadrare la situazione.
EOQ avrebbe dovuto essere chiamato flat bulk order. Infatti, dietro questo termine, che sembra catturare un intento ampio, si cela una formula semplificata che presuppone che la future demand sia costante (senza stagionalità), che il lead time futuro sia costante (senza variabilità), che il costo di ordinazione sia invariato (senza sconti per quantità) e, infine, che il carrying cost sia costante (senza scadenza). L’espressione flat bulk order trasmette adeguatamente la natura essenzialmente semplicistica della formula.
Order è una buona parola, ma usata da sola risulta profondamente ambigua. Esistono client orders, supplier orders, production orders, ordini di inventory movement, scrap orders, ecc. È necessario un prefisso qualificativo per dare senso all’espressione. Il termine “level” è abbastanza simile in questo contesto e non deve essere usato senza un prefisso qualificativo.
Safety stock avrebbe dovuto essere chiamato Gaussian buffer. Infatti, non c’è niente safe in questo metodo. Esso si basa sul presupposto che sia la [future demand] sia il [future lead time] siano distribuiti secondo curve normali (Gaussians), cosa che mai accade, poiché le distribuzioni d’interesse non seguono una distribuzione normale nel campo della supply chain. Il termine buffer chiarisce l’intento associato allo stock senza implicare alcuna virtù specifica per questo assetto.
Seasonality è un buon termine, ma solitamente il termine cyclicities risulterebbe più appropriato dal punto di vista della supply chain. Infatti, ha poco senso limitare l’analisi del modello di domanda alla ciclicità annuale, ossia alla seasonality. Il giorno della settimana e il giorno del mese sono altre ciclicità evidenti che devono invariabilmente essere prese in considerazione. Pertanto, un direttore della supply chain raramente cerca un’analisi della seasonality, ma piuttosto un’analisi delle cyclicities.
Service level avrebbe dovuto essere chiamato service rate, che sarebbe stato più coerente con fill rate. Il termine level suggerisce una quantità, come in stock level. Tuttavia, il service level è una percentuale. Probabilmente è uno dei casi meno gravi in questa lista, ma sarebbe preferibile poter esprimere in maniera più diretta la dualità service rate vs. fill rate.
Anche i neofiti della supply chain trarrebbero beneficio da una terminologia migliore.
DDMRP (demand driven material requirements planning) avrebbe dovuto essere chiamato sparse prioritized buffering. Infatti, questa metodologia non fornisce nulla di specifico per isolare la “vera” domanda rispetto al flusso: censura, cannibalizzazioni o sostituzioni non esistono nemmeno numericamente in questo framework. Allo stesso modo, la maggior parte degli approcci del planning è assente dal framework numerico: range planning, phase-in, phase-out, promotions, ecc. La parola chiave “sparse” qualifica in modo appropriato l’intento associato all’introduzione dei “decoupling points”.
I decoupling points avrebbero dovuto essere chiamati managed SKUs. DDMRP propone uno schema di graph coloring che suddivide gli SKUs in due gruppi: i decoupling points e il resto. Riferirsi a quei “points” come SKUs è più chiaro. Inoltre, poiché quegli SKUs sono gli unici destinati ad essere effettivamente controllati dal Supply Chain Scientist, l’espressione “managed SKUs” risulta appropriata e chiarisce che tutti gli altri SKUs sono “unmanaged” dal punto di vista del planner.
In certe situazioni, si possono ottenere semplificazioni drammatiche.
Artificial intelligence, autonomous system, blockchain, cognitive system, demand sensing, demand shaping, digital brain, knowledge graph, optimal algorithms possono essere sostituiti essenzialmente dalla parola magic. Sebbene al di fuori dei circoli della supply chain per alcuni di questi buzzword si possano trovare gradi variabili di vera ingegneria, nel contesto del software aziendale per la supply chain si tratta del puro vaporware.
Infine, alcuni termini rimangono adeguati anche se talvolta ricevono critiche.
Value Chain viene talvolta proposto come sostituto di Supply Chain. Tale sostituzione riflette una mancanza di comprensione della legge di Say, intitolata al lavoro di Jean Baptiste Say, un economista di fine ‘800. Questa legge può essere riassunta come supply is the source of demand. La supply viene prima, la domanda seconda, e il value infine, quando le transazioni avvengono. La chain lega l’intero affare. La value chain è principalmente promossa dai consulenti che cercano di vendere ROI ai loro potenziali clienti. Tuttavia, il termine “value” risulta essere sia meno specifico sia più positivamente distorto rispetto al suo omologo “supply”.